ECONOMIA... PARVA MATERIA
Premio Nobel per l'Economia 2022 a Bernanke, Diamond e Dybvig per le loro ricerche sulle banche e le crisi finanziarie
Un trio di economisti statunitensi, tra cui l'ex presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig (nella foto), ha vinto quest'anno il Premio Nobel per l'economia per la loro ricerca su come regolamentare le banche e sostenere i creditori in dissesto con denaro pubblico durante le crisi.)
Bernanke, il primo governatore centrale a ricevere il Nobel per l'economia, ha ottenuto il premio per “aver migliorato in modo sostanziale la nostra comprensione
del ruolo delle banche nell’economia, in particolare durante le crisi finanziarie, e su come regolare i mercati finanziari” e per i suoi studi del 1982 “sulla crisi del '29, la peggiore crisi economica della storia moderna”.
Gli altri due professori, Dybvig e Diamond dell'Università di Chicago, sono stati selezionati per il loro articolo fondamentale del 1983, "Corse agli sportelli (bank run), assicurazione dei depositi e liquidità", che ha introdotto un modello economico che spiegava perché le banche sono soggette a repentine richieste di denaro durante le crisi.
Il “modello Diamond-Dybvig”, costruito negli anni ottanta, è diventato sinonimo di studio delle crisi bancarie, finanziarie, della liquidità e delle corse agli sportelli. Il documento ha dimostrato che tutte le corse agli sportelli condividono lo stesso DNA, nonostante circostanze diverse e fattori scatenanti il panico. “Il nostro modello ha mostrato come considerare le
"corse agli sportelli" come un comportamento razionale. Se pensi che tutti gli altri ritireranno i loro soldi, lo farai anche tu, e questo è un comportamento razionale", ha affermato Dybvig.
“Il modello mostra che il bisogno di liquidità per le banche che le rende fragili è anche ciò che aggiunge valore all'economia. Abbiamo lavorato molto duramente per rendere il modello stesso semplice e efficace per il sistema bancario".
Genericamente possiamo affermare che le banche intermedino le esigenze finanziarie di prestito a lungo termine delle imprese con quelle a breve termine di deposito dei risparmiatori. Diamond e Dybvig sottolineano che in circostanze ordinarie, è probabile che le esigenze imprevedibili di contanti dei risparmiatori siano casuali, poiché le esigenze dei depositanti riflettono le loro circostanze individuali. Poiché è improbabile che la domanda di contanti dei depositanti si verifichi contemporaneamente, accettando depositi da molte fonti diverse la banca si aspetta solo una piccola parte dei prelievi a breve termine, anche se tutti i depositanti hanno il diritto di ritirare l'intero deposito in qualsiasi volta. Pertanto, una banca può concedere prestiti su un lungo orizzonte, mantenendo solo quantità relativamente piccole di contanti a disposizione per pagare i depositanti che desiderano effettuare prelievi. Matematicamente, i prelievi individuali sono in gran parte non correlati e secondo la legge dei grandi numeri le banche prevedono un numero relativamente stabile di prelievi in un dato giorno. Tuttavia è possibile anche un esito diverso. Dal momento che le banche prestano a lunga scadenza, non possono richiedere rapidamente i loro prestiti. E anche se provassero a richiedere i loro prestiti, i mutuatari non sarebbero in grado di rimborsare rapidamente, poiché i loro prestiti sono stati, per ipotesi, utilizzati per finanziare investimenti a lungo termine. Pertanto, se tutti i depositanti tentano di prelevare i propri fondi contemporaneamente, una banca finirà i soldi molto prima di essere in grado di pagare tutti i depositanti. La banca sarà in grado di pagare i primi depositanti che chiedono indietro i loro soldi, ma se anche tutti gli altri tentano di ritirarsi, la banca fallirà e gli ultimi depositanti non rimarranno senza nulla.
Ciò significa che anche le banche sane sono potenzialmente vulnerabili al panico, solitamente chiamato “corsa agli sportelli” (bank run) . Se un depositante si aspetta che tutti gli altri depositanti ritirino i propri fondi, è irrilevante se è probabile che i prestiti a lungo termine delle banche siano redditizi; l'unica risposta razionale per il depositante è affrettarsi a ritirare i propri depositi prima che gli altri depositanti rimuovano i loro. In altre parole, il modello Diamond-Dybvig vede le “corse agli sportelli” come una sorta di profezia che si autoavvera : l'incentivo di ciascun depositante a prelevare fondi dipende da ciò che si aspetta che facciano gli altri depositanti. Se un numero sufficiente di depositanti si aspetta che altri depositanti ritirino i propri fondi, tutti hanno un incentivo a correre per essere i primi a ritirare i propri fondi.
In termini teorici, il modello Diamond–Dybvig fornisce un esempio di gioco economico con più di un cosi detto “equilibrio di Nash”: se i depositanti si aspettano che la maggior parte degli altri depositanti ritiri solo quando hanno reali esigenze di spesa, allora è razionale che tutti i depositanti ritirino solo quando hanno reali esigenze di spesa. Ma se i depositanti si aspettano che la maggior parte degli altri depositanti si affretti a chiudere i propri conti, allora è razionale che tutti i depositanti si affrettino a chiudere i propri conti. Naturalmente il primo equilibrio è migliore del secondo (nel senso dell'efficienza paretiana). Se i depositanti si ritirano solo quando hanno reali esigenze di spesa, tutti traggono vantaggio dal detenere i propri risparmi in un conto liquido fruttifero. Se invece tutti si precipitano a chiudere i conti, allora tutti perdono gli interessi che avrebbero potuto guadagnare, e alcuni di loro perdono tutti i risparmi. Tuttavia, non è ovvio cosa potrebbe fare un depositante per prevenire questa perdita reciproca.
In pratica, a causa della riserva frazionaria bancaria, le banche di fronte a una corsa agli sportelli di solito chiudono e si rifiutano di consentire ulteriori prelievi. Questa si chiama sospensione della convertibilità e genera ulteriore panico nel sistema finanziario. Sebbene ciò possa impedire ad alcuni depositanti che hanno un reale bisogno di contanti di ottenere l'accesso al loro denaro, impedisce anche il fallimento immediato, consentendo così alla banca di attendere il rimborso dei suoi prestiti, in modo da avere risorse sufficienti per rimborsare alcuni o tutti i suoi depositi.
Tuttavia, Diamond e Dybvig sostengono che, a meno che non sia noto con certezza l'importo totale delle esigenze di spesa reale per periodo, la sospensione della convertibilità non può essere il meccanismo ottimale per prevenire le “corse agli sportelli”. Al contrario, sostengono che un modo migliore per prevenire le corse agli sportelli è la garanzia sui depositi fornita dalle banche centrali o dallo Stato. Tale assicurazione paga ai depositanti tutte o parte delle loro perdite in caso di “corsa agli sportelli”. Se i depositanti sanno che riprenderanno i loro soldi anche in caso di corsa agli sportelli, non hanno motivo di affrettarsi ad accorrere in banca. D'altra parte, non è da trascurare, che è probabile che l’esistenza di un fondo di protezione sui depositi porti all'azzardo morale da rendere sia i depositanti meno attenti nella scelta di dove depositare i loro soldi, sia le banche meno attente a chi presteranno poi i soldi dei loro depositanti.
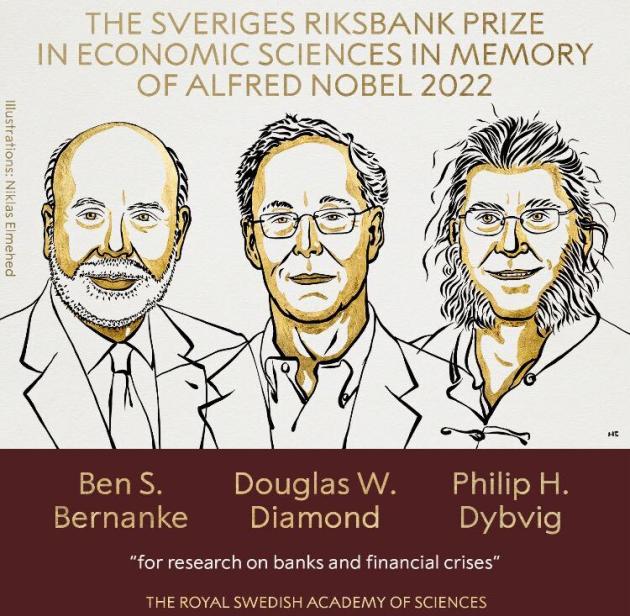
Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig in Journal of Political Economy, Volume 91, Number 3Jun., 1983
Per una slow-finance e il valore delle relazioni sul consumo
In un momento dove il “pensare economico” di ciascuno di noi influenza i destini di un Paese, è buona regola domandarsi sempre: è giusto? Ogni decisione economica ha sempre una conseguenza di carattere morale. Un sistema senza etica dimostra che in un mondo globalizzato, il singolo comportamento spregiudicato o illecito può amplificarsi fino a mettere in crisi intere economie.
Certo la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci! Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L’avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. (1° lettera di San Paolo apostolo a Timotèo).
 Oggi sempre più ci si chiede come dare il giusto valore al lavoro e al denaro nella vita delle persone. Con la tecnologia è aumentata la produttività, ma il tempo lavorativo si è espanso anche in periodi una volta deputati al riposo: aperture 24 ore su 24 dei negozi, turni notturni in fabbrica, consumare i pasti in ufficio, pressioni alla rinuncia volontaria delle ferie. In sintesi più lavoro, più soldi, ma meno tempo a disposizione, questa visione miope, ha ricadute negative non solo sui consumi ma anche sulla qualità della vita, in termini di tempo sottratto a sè stessi, alla famiglia e all’impegno civile di ciascuno.
Oggi sempre più ci si chiede come dare il giusto valore al lavoro e al denaro nella vita delle persone. Con la tecnologia è aumentata la produttività, ma il tempo lavorativo si è espanso anche in periodi una volta deputati al riposo: aperture 24 ore su 24 dei negozi, turni notturni in fabbrica, consumare i pasti in ufficio, pressioni alla rinuncia volontaria delle ferie. In sintesi più lavoro, più soldi, ma meno tempo a disposizione, questa visione miope, ha ricadute negative non solo sui consumi ma anche sulla qualità della vita, in termini di tempo sottratto a sè stessi, alla famiglia e all’impegno civile di ciascuno.
L’uomo vive sempre in bilico fra passione e ragione. La prima lo spinge a soddisfare i propri desideri ed impulsi, invitandolo a conseguire la felicità; la seconda lo richiama al dovere, alla virtù, e si presenta nella forma del comando, dell’imperativo. Per Kant, felicità individuale e virtù sono cose diverse e non assimilabili: l’azione umana è molto spesso orientata a conseguire scopi particolari, e non è in base ad essa che sia possibile determinare la moralità o l’immoralità dei comportamenti.
Dal punto di vista economico, uno degli ambiti di ricerca più rilevanti e interessanti degli ultimi tempi è il rapporto tra reddito e felicità. Anche se quest’ultima non sia misurabile in maniera oggettiva, gli studi evidenziano una relazione molto più complessa di quella generalmente definita nelle funzioni di utilità dei modelli standard. Alla mera correlazione positiva via via decrescente, solitamente postulata dagli economisti, si innestano almeno altre due componenti rilevanti: una di carattere psicologico e un’altra di carattere sociologico. Secondo la prima, esiste una rincorsa tra aspirazioni e realizzazioni: una volta raggiunta una meta in termini di reddito, gli individui alzano progressivamente l’asticella dei loro traguardi successivi, riducendo il grado di soddisfazione per quanto già raggiunto. Per la sociologia, nel rapporto tra reddito personale e felicità, è fondamentale il confronto con il livello di reddito del gruppo di riferimento, l’insieme di persone con il quale l’individuo si rapporta solitamente: è la distinzione tra reddito personale e reddito nazionale, e quest’ultimo ha sicuramente un impatto superiore al primo sulla felicità, in quanto non presenta le problematiche di reddito relativo, e presumibilmente, consente di migliorare l’accesso e qualità dei servizi pubblici, un fattore che incide positivamente anche sulla felicità individuale.
Le prescrizioni di politica economica sono sempre fondate, implicitamente o esplicitamente, su di una scala di valori incorporata in una funzione di benessere sociale da massimizzare; non identificare questi obiettivi, significherebbe perdita di consenso elettorale perché gli obiettivi si definiscono sulla base di criteri di felicità corrispondenti alle reali preferenze degli individui. Sino a poco tempo fa, gli economisti, in mancanza di osservazioni empiriche affidabili, avevano definito a priori le preferenze, sulla base di una loro visione antropologica. Se viene raggiunto un grado sufficiente di condivisione, attraverso il consenso elettorale, allora gli scopi diventano giusti e le conseguenze moralmente accettabili. Con ciò l’etica pubblica laica e democratica risolve il problema della moralità dei comportamenti pubblici: è bene ciò che è accettato come bene dalla maggioranza della comunità, di conseguenza la politica riesce a fare a meno di confrontarsi direttamente con una idea etica del vivere.
Il primo fattore necessario al perseguimento della felicità pubblica è la “crescita”, il primo ed essenziale obiettivo di ogni politica economica. Senza crescita, non c’è sviluppo, non c’è ricchezza nè benessere. Il moderno sistema industriale capitalista richiede, come condizione indispensabile, una crescita annua positiva dell’economia in base al Prodotto Industriale Lordo, il PIL. Quando il tasso di crescita tende a zero, l’economia entra in stagnazione e il sistema rischia di andare in crisi.
L’economia e la finanza dovrebbero crescere all’infinito, ma fino a quando è possibile in un mondo fatto di risorse limitate? L’enorme disponibilità di risorse energetiche e l’incredibile progresso tecnologico hanno permesso, fino ad oggi, di mantenere all’incirca costante il tasso di crescita, creando la percezione che l’economia potesse procedere senza tener conto dei limiti ambientali, quando invece solo la finanza è l’unico sistema illimitato conosciuto. Oggi coesiste un sistema produttivo retto dalle leggi della fisica e della natura con orizzonti limitati che, nonostante imprevedibili progressi scientifici, non potrà prescindere dalla quantità delle risorse esistenti, ed un sistema finanziario, la cui innovazione, spesso legata a prodotti e transazioni scarsamente trasparenti, consente una moltiplicazione illimitata del denaro come nessuna altra attività produttiva potrebbe mai permettersi.
La natura non è un sostituto perfetto del capitale, non è un fattore produttivo illimitato. Frederick Soddy, nobel per la chimica, già nel 1926 aveva spiegato questa relazione: la crescita dell’economia reale si basa sulla crescita della produzione e del consumo che a sua volta implica un aumento dello sfruttamento del lavoro umano e della natura, la valutazione economica dell’utilizzo delle risorse e dell’inquinamento provocato è notevolmente sottostimata, ed è questo errore che rende possibile la continua crescita del PIL.
La finanza invece cresce sull’effetto leva del credito, scommettendo su una crescita indefinita nel futuro che permetta di restituire gli interessi e i debiti accumulati. Quando l’economia reale cresce, riesce a ripagare i debiti contratti, quando rallenta, i debiti si accumulano con un effetto amplificativo. Data la stabilità del volume dei salari e della spesa pubblica negli ultimi anni, il divario oggi esistente tra gli incrementi delle masse monetarie e la produzione reale non può che spiegarsi con la speculazione. Sono già in molti a sostenere che tutta la ricchezza reale mondiale non sia da tempo più sufficiente a garantire l’enorme debito generato dal sistema finanziario, ed anche se lo fosse, il prezzo per ripagarlo in termini di riduzione di benessere sarebbe altissimo.
Essendo le produzioni sempre più delocalizzate, l’economia dei servizi non potrà portare da sola a significativi sviluppi di crescita, perché si basa su attività caratterizzate da forti componenti umane. I nostri mercati sono pieni di prodotti d’importazione, mentre i nostri servizi non sono esportabili e non può esserci crescita in un Paese fatto di soli servizi e consumi. Ritorno alla produzione in Italia, vuol dire mettere mano ad una riorganizzazione sul territorio con nuovi modelli di partecipazione e democrazia. Le nuove produzioni dovranno essere sempre di più finalizzate ai mutamenti ecosistemici, decisivi per aprire concretamente nuove strade di crescita verso modelli sociali differenti, anche oltre le logiche del puro profitto capitalistico. Non è il ritorno meccanico ad una tradizionale forza-lavoro industriale, ma una crescita verso i lavori collegati ai nuovi materiali, alle nuove produzioni, a dinamiche di mobilità sostenibili e di manutenzione del territorio, anche con grandi opere, “certe” e fatte in tempi ragionevoli, orientate alla conversione delle vecchie strutture capitalistiche che non possano produrre nuovo sviluppo.
Il capitalismo è rimasto l’unico modello praticabile perché ha saputo trasformarsi e adattarsi alla storia. Dalla rivoluzione industriale in poi ha sollevato dalla povertà miliardi di persone. Un giorno la lotta per la sopravvivenza non sarà più un imperativo primario e appariranno più impellenti altri tre aspetti che oggi non sono ancora ai primi posti nelle agende politiche. Un primo aspetto, è la preservazione dell’ecosistema del pianeta e la diseguaglianza reddituale tra le persone. Quest’ultimo è in parte il semplice effetto collaterale di innovazione ed imprenditorialità, ma i grandi patrimoni permettono a gruppi o individui di acquistare potere politico e influenza che a loro volta aiutano a generare ancora più disparità. Un secondo aspetto, sono i costi della sanità destinati a crescere con l’invecchiamento della società, probabilmente superando il 30% del PIL in pochi decenni. Infine, il sistema capitalistico odierno sottovaluta enormemente il benessere delle future generazioni. Questo non ha mai avuto storicamente importanza poiché i continui benefici dell’avanzamento tecnologico hanno trionfato sulle politiche miopi. In generale, ogni generazione si è trovata meglio di quella precedente, ma con la popolazione mondiale che raggiungerà a breve i sette miliardi, stanno divenendo sempre più evidenti i primi segnali di un globale impoverimento, soprattutto della classe media occidentale.
In linea di principio, nessuno dei problemi del capitalismo è insormontabile, gli economisti hanno sempre offerto una varietà di soluzioni basate sul mercato, ma non si può più pensare ad una crescita continua ed indefinita, un paradigma comune sia ad una visione liberista che marxista. Abbiamo una quantità tale di beni da esserne saturi e stiamo procurando una serie di danni ecologici, sociali e psicologici tali da mettere in discussione anche il consumo futuro. La soddisfazione raggiunta con il consumo di un dato bene o servizio deve cessare il più in fretta possibile per far posto ad altri desideri o ad altri bisogni. Un aumento del PIL non è altro che una diminuzione dell’energia non rinnovabile a disposizione dell’umanità. Il PIL è il misuratore dello sviluppo indefinito basato su un aumento di consumi futili e non necessari che sottovaluta le reazioni degli esclusi.
Nel 1970, l’economista svedese Staffan Linder aveva mostrato come l’aumento della intensità di consumo conduca alla sua inevitabile diminuzione; il benessere è sempre più legato alla disponibilità del tempo piuttosto che al possesso. La grande differenza fra l’attuale stadio del capitalismo e quello auspicabile futuro, è che oggi i soggetti economici cercano in ogni modo di esternalizzare produzioni e costi per generare economie di scala private, mentre nel futuro, la consapevolezza delle deficienze di questo sistema egoistico di sfruttamento del mondo, imporrà ai nuovi leader di internalizzare nelle decisioni tutti i punti i vista.
Puntiamo alla crescita, ma il nostro Paese è già da qualche anno in decrescita in termini reali. Gli indici delle borse valori di tutto l’occidente, che dovrebbero riflettere gli andamenti reali dell’economia, si trovano su livelli assoluti pressoché uguali rispetto a quelli di 15 anni fa; ciò sembra coerentemente indicare che anche i mercati finanziari registrino questa situazione di “non-crescita”. Altri segnali sono presenti anche nella vita di tutti i giorni: l’aumento considerevole del costo della vita, fenomeni di degrado degli ambienti naturali e sociali, la riduzione dei vincoli di tutela ambientale e dei diritti sociali già acquisiti, le dismissioni pubbliche dei beni demaniali e culturali in corso in molti paesi sviluppati.
Accettare un’eventuale decrescita, non significherebbe accettare il declino del Paese e rinunciare al benessere acquisto, significherebbe ridisegnare il proprio futuro pensando più a cosa lasceremo ai nostri figli che al presente, cominciando non solo a preservare le risorse naturali ma soprattutto a pensare ad un miglior utilizzo di quelle pubbliche. Lo Stato non può sostituirsi all’iniziativa privata, ma può dare i giusti impulsi: un miglior e chiaro quadro normativo, creare le infrastrutture, non solo tecniche, ma soprattutto culturali attraverso una scuola di qualità. Tuttavia non si può più prescindere dai limiti imposti dal sistema stesso: una pressione fiscale ormai insopportabile e uno stock di debito pubblico non più amplificabile. Ciò significa un’unica ricetta improcrastinabile: maggiore efficienza nella gestione pubblica, meno burocrazia, meno politica e meno evasione fiscale. Questo è il vero problema del nostro paese. Ogni anno la Banca Mondiale pubblica un report doing business dove valuta la facilità di intraprendere una nuova iniziativa economica su un panel di 187 nazioni analizzando dieci indicatori del quadro normativo relativo all’intero ciclo vitale delle imprese. I dati del rapporto hanno lo scopo di segnalare agli imprenditori dell’economia globalizzata dove conviene o non conviene investire, considerano l’applicazione della normativa vigente. Il nostro Paese si è collocato nel 2011 all’ottantasettesimo posto, in calo di quattro posizioni dall’anno precedente, e di gran lunga lontano dagli altri paesi più sviluppati. Nel corso del 2011 molti governi, a seguito della crisi finanziaria internazionale, hanno adottato politiche tese a favorire le piccole medie e imprese e a sostenere l’occupazione. Più della metà delle riforme si sono concentrate: nel facilitare lo start up di un’impresa, nel semplificare le regole commerciali e il pagamento delle tasse, nello snellire le procedure fallimentari. Singapore è saldamente al primo posto da cinque anni, seguono Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Danimarca, primo fra gli Stati europei. Il Regno Unito si colloca al settimo posto, mentre la Germania è al 19esima posizione davanti al Giappone, 29esima la Francia. I voti più bassi per l’Italia sono dati: dalle “procedure di attuazione dei contratti”, dal “pagamento delle tasse” e dall’“accesso all’energia elettrica”. Per i tempi e costi della giustizia civile ci troviamo al 158esimo posto nel far rispettare i contratti per via giudiziale, con 1.210 giorni di iter procedurale ed un costo in media del 30% dell’importo non pagato. Si aggiunga inoltre che il carico fiscale totale effettivo, al 68,5% dei profitti, ci colloca al 134esimo posto. Ciò significa che per le imprese il costo riguarda non solo “quanto” pagare ma anche “come” pagare. Altre situazione negative per l’Italia riguardano: l’avvio di un’attività imprenditoriale (77esimo posto), i permessi di costruzione (96esimo posto), l’allacciamento all’elettricità (109esimo posto), la registrazione degli immobili e l’accesso al credito (98esimo posto).
Crescita non significa necessariamente gigantismo industriale per competere nella globalizzazione. La necessità di capitali fissi sempre maggiori, funzionali alla crescita obbligata delle imprese, richiede aspettative di ritorni finanziari attesi anch’essi sempre maggiori, da cui derivano: superproduzione, incapacità di smaltire le scorte, prodotti invenduti, rifiuti generati, competizione esacerbata, trade-off fra capitale e lavoro, fra lavoro e lavoro ed una insopprimibile tendenza a una nuova e maggiore concentrazione. E’ l’altra faccia dell’accresciuta disuguaglianza, che nessuna legislazione antitrust o politica redistributiva è in grado di ridurre, anche in presenza di una massiccia crescita economica.
Una crescita moderata o addirittura una decrescita, dovrebbe essere programmata non soltanto per preservare l’ambiente, ma anche per ripristinare un minimo di giustizia sociale senza la quale il pianeta è condannato all’esplosione: sopravvivenza sociale e sopravvivenza biologica sono strettamente legate. I limiti del patrimonio naturale non pongono soltanto un problema di equità intergenerazionale nel condividere le disponibilità, ma anche un problema di giusta ripartizione tra gli esseri viventi dell’umanità.
Decrescita non significa un immobilismo conservatore; la saggezza tradizionale considerava che la felicità si realizzasse nel soddisfare un numero ragionevolmente limitato di bisogni. L’evoluzione e la crescita lenta delle società antiche, si integravano in una produzione allargata ben temperata, sempre adattata ai vincoli naturali. Organizzare la decrescita oggi significa, in altre parole, rinunciare all’immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. Bisogna riscoprire la vera ricchezza nei rapporti sociali conviviali in un modo sano con serenità nella frugalità, nella sobrietà e addirittura con una certa austerità nel consumo materiale. La sobrietà non è solo un mezzo che libera delle risorse, è anche una fedeltà a sè stessi, una libertà personale che affermi il primato dello spirito, è il rispetto della propria dignità umana non traviata dall’uso della ricchezza al punto tale da essere disumanizzati. San Tommaso sapeva che chi vive in castità e con moderazione soccombe più difficilmente al peccato di sperperare e si rivela anche in altri modi migliore amministratore. San Paolo affermava, nella prima lettera a Timotèo, che i cristiani debbano imparare ad essere contenti con il vivere semplice e di non cadere nella trappola di accettare lo standard del mondo per sè stessi. Virtù, che a differenza della mera autodeterminazione, sono tutt’altro che innate e richiedono lo sforzo di una vita orientata verso l’orizzonte esistenziale della felicità, fine ultimo necessario di ogni uomo.
Non è una singola azione onesta che ci rende onesti, ma una serie abituale di azioni oneste che creano in noi la virtù dell’onestà e quindi ci rendono uomini onesti. Oltre alla prodigalità, la morale cristiana combatte anche altri nemici della concezione borghese della vita come l’ozio. Accanto all’industriosità e alla parsimonia gli Scolastici insegnarono la virtù del decoro, dell’onestà e dell’onorabilità. Non possiamo negare che il capitalismo e la civiltà occidentale siano emerse spontaneamente dal basso, dalla tradizione giudaico-cristiana, quando sul piano della cultura si sono diffusi e affermati determinati precetti morali come: la responsabilità individuale, lo sforzo e l’impegno personale, l’affidabilità, la fedeltà, l’onestà, la prudenza, la lungimiranza, l’autodisciplina morale.
Nel regno del dominio dell’etica pubblica, e del conseguente confinamento dell’etica dei principi nella sfera dei comportamenti individuali, il problema del giudizio di valore su qualsiasi attività umana, non ha più come oggetto le conseguenze pratiche dei comportamenti concreti messi in atto per ottenere lo scopo predeterminato, ma solo gli obiettivi. In pratica, alla politica viene chiesto solo di rendere pubblici e di giustificare i motivi ultimi del loro agire e di cercarne la condivisione delle comunità sociali di riferimento tramite il consenso elettorale.
Affinché il sistema dell’economia globale produca uno sviluppo equo e sostenibile, è dunque necessario l’impulso dal basso dei cittadini-consumatori. L’economia solidale è fondata su relazioni di reciprocità: nei rapporti di scambio si dà al fine di ricevere. Nelle relazioni di reciprocità si dà per il gusto di dare, dove tuttavia questo piacere è inseparabile dalla risposta, sempre incerta, dell’altro. Ovviamente solo comportamenti generalizzati finiranno per influenzare in maniera decisiva i comportamenti di imprese e istituzioni che dovranno necessariamente tener conto delle preferenze dei consumatori per realizzare i propri obiettivi tradizionali. Finché il comportamento etico avverrà in termini di nicchia, si potrà soltanto avere un effetto marginale, del tutto trascurabile ai fini dell’orientamento del sistema nella sua globalità.
Oggi gli individui non solo consumano beni per necessità, ma essenzialmente per meglio “posizionarsi” nella scala sociale. La domanda di posizionalità non è soddisfatta da una crescita della ricchezza della società, ma dalla propria in relazione a quella degli altri: se il mio reddito aumenta, ma quello del mio collega d’ufficio aumenta di più, potrei ritrovarmi con più reddito ma con più frustrazione.
Gli individui non avendo un insieme finito di bisogni, non si sentono mai soddisfatti dell’identità che posseggono, ma sono attratti da quella che hanno gli altri “che contano”. La cultura consumistica è contrassegnata dalla costante pressione ad essere qualcun altro. I mercati dei beni di consumo sono imperniati sulla svalutazione delle loro precedenti offerte in modo da creare, nella domanda del pubblico, uno spazio che sarà riempito dalle nuove offerte.
Puntare al differenziale di consumo, all’egoistico interesse personale, porta soltanto ad una diminuzione di felicità pubblica. Ad esempio il giovane che durante un concerto si alza in piedi per vedere meglio (“felicità personale”) produrrà l’effetto che tutti faranno altrettanto, per cui tutti vedranno il concerto in piedi con una diminuzione generale di “felicità pubblica”. Il conflitto tra individuo e gruppo è la più importante spiegazione dello squilibrio nei nostri attuali piani di consumo. Non è difficile spiegare, con questo approccio, perché la globalizzazione faccia diminuire la felicità: aumentando le persone con cui confrontiamo il nostro reddito relativo, fino a far coincidere il nostro villaggio con il mondo intero, è ovvio che i primi della lista saranno sempre di meno e i secondi sempre di più.
Beni come l’auto di alta cilindrata, la barca o il cellulare di ultima generazione, sono spesso acquistati non per il possesso di particolari caratteristiche intrinseche, ma innanzi tutto per la loro capacità di fungere da efficaci certificatori di status socio-economico. Tali beni, attraverso il contenuto simbolico ad essi associato dalle norme sociali vigenti, contribuiscono infatti a veicolare una determinata immagine sociale per chi li possegga legittimamente, a prescindere dall’esistenza o meno di un’effettiva corrispondenza tra tale immagine e la vera identità sociale del loro proprietario. Anche il potere e la notorietà sono desiderabili in quanto non universalmente fruibili. Solo se tutti i soggetti appartenenti al proprio gruppo sociale di riferimento, fossero egualmente potenti o egualmente famosi, quel bene perderebbe immediatamente la propria capacità di attrazione e il suo valore si azzererebbe. Un bene rappresenta uno status symbol solo nella misura in cui un numero limitato di persone possa accedervi. E’ lo stesso meccanismo posto alla base della crescita economica che rischia contestualmente di determinare un’impossibilità di aumento generalizzato del benessere, in quanto i “beni posizionali”, anche se facilmente riproducibili, sono “socialmente” scarsi e non compatibili con una diffusione su larga scala.
Per poter ambire ai beni di status ci sottoponiamo a fatiche, rinunce, a più lavoro: è la leva che muove i popoli verso l’opulenza e il benessere, di conseguenza una quantità di tempo spropositata è destinata al perseguimento dell’obiettivo di guadagnare di più a spese della vita familiare e della salute, con la conseguenza che il benessere soggettivo si riduca rispetto al livello atteso. E’ un meccanismo che si regge su un semplice autoinganno: l’idea che il ricco sia più felice.
Quando abbiamo un reddito minore ci accontentiamo, quando aumenta, cerchiamo di aumentare il nostro benessere, ma dopo poco avremmo la stessa soddisfazione perché siamo portati a richiedere continui e più intensi piaceri per mantenere lo stesso livello di soddisfazione, con l’effetto di un uso non efficiente della ricchezza. Solo nei rapporti affettivi e civili non opera questo totale riassorbimento, è ampiamente noto che in media le persone che vivono rapporti profondi e stabili siano relativamente più felici, come lo siano anche le persone altruiste e quelle che fanno volontariato.
Oggi il povero ha scarsità di denaro e abbondanza di tempo, il ricco ha abbondanza di denaro e scarsità di tempo; il ricco di ieri, invece, aveva sia denaro sia tempo in abbondanza. Per consumare volumi crescenti di beni e servizi ci vuole sempre più tempo, col risultato che il tempo è diventato denaro sia sul lavoro, sia nel consumo. Ciò spiega la nascita, a getto continuo, di nuove attività e prodotti il cui scopo è proprio quello di far risparmiare tempo nel processo di consumo. La società dei consumi avrebbe bisogno che la soddisfazione del consumatore fosse istantanea. La soddisfazione raggiunta con il consumo di un dato bene o servizio, deve cessare il più in fretta possibile per far posto ad altri desideri o ad altri bisogni, al consumo di altri beni e servizi. Consumando più in fretta, si possono accrescere i volumi di consumo e di conseguenza aumentare l’offerta di beni. L’aumento dell’intensità del consumo conduce ad un esito paradossale: il tentativo di consumare quantità sempre maggiori di beni entro un medesimo tempo di consumo, fa diminuire sia l’utilità del consumatore, sia il tempo libero dedicato ad attività non consumistiche
Oggi gli individui sono più consapevoli della necessità di dedicarsi maggiormente a consumi relazionali come: turismo, amici, cultura, ma hanno meno tempo per farlo, da qui la frustrazione soggettiva di vedere la propria vita presa dal lavoro e dal consumismo. Ieri la vita era assorbita prevalentemente dal solo tempo di lavoro, quella del consumo veniva considerata come un’attività volta alla soddisfazione di bisogni, più o meno necessari; nella teoria economica, il consumo è sempre stato concettualizzato come attività economica improduttiva. Ora il consumo è un “mezzo di produzione” perché i beni “hanno bisogno” di essere consumati e se il bisogno non è spontaneo o se di questi beni non se ne sente la necessità, occorrerà che questo bisogno sia generato in un modo o nell’altro. Dal consumismo si è passati all’iperconsumismo, la nostra felicità, il nostro vivere, dipende da quello che consumiamo non dalle relazioni che sacrifichiamo per farlo.
Miglioramenti delle circostanze oggettive della vita, reddito e ricchezza inclusi, non sembrano produrre effetti reali sul benessere delle persone all’interno di un singolo Paese. In un dato momento nel tempo, la correlazione tra reddito e felicità esiste, ma nel confronto tra Paesi non c’è la stessa correlazione significativa: alcuni Paesi poveri non risultano essere meno felici di quelli più ricchi; inoltre nel corso del ciclo di vita, la felicità delle persone sembra dipendere molto poco dalle variazioni di reddito. Come spiegare il paradosso di queste affermazioni apparentemente contraddittorie rispetto al paradigma della ricchezza? E’ forse vero che i soldi non facciano la felicità? Molti infatti ritengono che non siano “solo” i soldi a fare la felicità ma la facciano soprattutto i “beni relazionali”, quei beni che possono essere posseduti solo attraverso intese reciproche tra le persone. Questi “beni” non sono “merci”, hanno un valore perché soddisfano un bisogno, ma non hanno un prezzo di mercato in quanto gratuiti. Le merci, dove ognuno può offrire in maniera anonima, non sono relazionali. I “beni relazionali” non sono beni che possano essere prodotti o consumati da un solo individuo perché dipendono dalle modalità delle relazioni con gli altri, e con gli altri possono essere goduti solo se condivisi. A differenza delle merci, dove la produzione è tecnicamente e logicamente distinta dal consumo, i “beni relazionali” si producono e si consumano simultaneamente. Le loro caratteristiche essenziali sono la reciprocità e le motivazioni: una cena tra amici è un bene relazionale una cena d’affari no. Un altro tratto distintivo è che il consumo di “beni relazionali” di un soggetto, aumenti con l’aumentare del tempo che quel soggetto dedica alla socializzazione e con lo sforzo di socializzazione espresso da altri soggetti. I tipici “beni relazionali” sono infatti: l’amicizia, la famiglia, l’amore ed è proprio la relazione a costituire il bene. E’ difficile amare, essere amico o parente di un computer, ed è impossibile essere amico di qualcuno in modo unilaterale; la dimensione della reciprocità è fondativa. I “beni relazionali” tendono ad aumentare il loro valore con l’uso, la loro “utilità marginale” è crescente a differenza dei beni privati per i quali essa è normalmente decrescente; in questo senso il valore dei “beni relazionali” aumenta con l’esercizio, ma si deprezza con il “non uso”: meno tempo investo con gli amici, più mi costerà costruire un nuovo rapporto di amicizia o tenere in vita quello esistente e di conseguenza, maggiore diventerà il costo in termini di felicità dei beni sostituti. Un tale meccanismo fa sì che il consumo di “beni relazionali” possa progressivamente diminuire. Ad esempio, gli amici “virtuali” su internet possono essere considerati dei beni sostituti a minor costo dei “beni relazionali”, ma potrebbero nel tempo crescere troppo a spese degli amici reali, con effetti evidenti in termini di felicità.
In definitiva “relazionale” è il bene che gode del vantaggio che ciascun consumatore che ne tragga utilità dal suo uso, non possa essere separato dal vantaggio che altri ne traggono da esso. In altri termini, se nell’ambito di classici “beni relazionali” primari come i rapporti intrafamiliari o relazioni di amicizia profonde, viene meno la componente affettiva del rapporto stesso, non si modifica semplicemente il valore del bene consumato, ma è l’intero rapporto che si dissolve.
Il maggior uso di “beni relazionali” porta all’autorealizzazione della persona, l’eudaimonìa degli antichi greci, una “vita realizzata”, una “vita degna di essere vissuta”, capace di essere in sintonia con le più profonde caratteristiche dell’essere umano. Oggi purtroppo la vita lavorativa è stata tenuta separata dall’idea di “buona esistenza”, il lavoro ha subito un progressivo processo di impoverimento esistenziale con drammatiche conseguenze sulla più generale qualità del nostro vivere. La felicità si nutre di relazioni che, come tali, non sono immaginabili al di fuori dell’ambiente: è la natura a rendere possibile la reciprocità che libera l’uomo dall’isolamento, l’eudaimonìa Aristotelica che trae forza dalla virtù. Senza una gestione etica dei beni ambientali, dunque, non può esistere felicità. Interessante è la differenza tra l’approccio di Platone e quello di Aristotele al raggiungimento dell’eudaimonìa. Platone, consiglia al filosofo il distacco dalle circostanze esterne, Aristotele invece afferma la natura sostanzialmente relazionale e sociale dell’eudaimonìa: essa dipende soprattutto dalle virtù civili, dai rapporti profondi e non strumentali, dalle relazioni tra gli individui. Oggi purtroppo l’uomo moderno non ricerca più la felicità tramite la morale, ma è figlio dell’etica deontologica che lega insieme virtù, bene e dovere. Prima dell’era moderna era la religione che definiva le regole di vita, oggi l’uomo è sempre più individualista.
Nella società globalizzata, assistiamo ad una crescente diminuzione di “beni relazionali”, a favore dei “beni posizionali” che conferiscono utilità per lo status che creano nella scala sociale e che il loro consumo consente di occupare. I “beni relazionali” costano più dei “beni posizionali”, perché richiedono un maggiore investimento iniziale, perché sono vulnerabili e anche molto rischiosi: posso investire tempo e risorse in un rapporto affettivo che poi non vada a buon fine, divenendo addirittura fonte di infelicità, questo determina una distorsione negativa a favore dei beni sostituti di mercato, che vengono consumati in quantità eccessiva come accade tutte le volte che i prezzi sono troppo bassi o sotto costo.
La crisi attuale di valori della famiglia, della comunità, della fede, é profondamente legata alla crisi dei rapporti interpersonali. Le povertà che le nostre società opulente stanno sperimentando in modo cresceste è la povertà non di merci ma di relazioni. Nelle economie avanzate contemporanee, si assiste in misura crescente alla produzione e al consumo di veri e propri surrogati a basso costo di “beni relazionali”: invece che amici “reali” abbiamo quelli “virtuali” su facebook, invece che relazioni amicali, parliamo dei protagonisti del “grande fratello”.
Molti credono che la quantità compenserebbe la mancanza di qualità. Se ogni relazione è debole, cerchiamo di averne a non finire in modo che possiamo trovare sempre qualcosa che ci soddisfi, ma funziona esattamente al contrario: un soggetto che non possegga più legami significativi, ma viva nell’effimero di rapporti temporanei, si condanna a reiterare all’infinito scelte a breve termine diventando così incapace di fondare qualunque cosa destinata a durare.
La promessa del mercato è che la felicità dipenda dal consumo di “beni posizionali”, e pur di poter conseguire il reddito necessario per quei beni, dobbiamo sacrificare i “beni relazionali” come famiglia e amicizia; ma siccome la felicità dipende in buona parte da quei beni sacrificati, ne deriva il paradosso: siamo più ricchi ma siamo sempre meno felici.
Se è vero che staremmo meglio lavorando meno e coltivando di più i nostri rapporti interpersonali genuini, perché spesso facciamo esattamente il contrario? L’economista americano Tibor Scitovsky ci da una risposta distinguendo “beni di comfort” e “beni di creatività”. I primi producono sensazioni piacevoli nel breve periodo ma i benefici che generano si rivelano effimeri: un bel vestito, una TV nuova, una cena al ristorante, un’automobile: più si usano più annoiano. I “beni di creatività” invece, di solito possiedono la caratteristica opposta: la loro utilità marginale è crescente, nel senso che più ne faccio uso, più questi mi arrecano benessere, sono ad esempio le esperienze di tipo culturale: la musica, la lettura, lo sport. Scitovsky sostiene che consumiamo troppi “beni di comfort” e pochi “beni di creatività” perché le esigenze delle nostre economie spingono nella direzione di rendere molto poco accessibili, o estremamente cari, i “beni di creatività”, alimentando processi di sostituzione con i “beni di comfort”. Ad esempio, la produzione di musica un tempo era costosa per la strumentazione, ora si ottiene lo stesso risultato con il sintetizzatore. Prima era costoso invitare cantanti ai spettacoli televisivi, ora ci sono trasmissioni che permettono di cantare canzoni famose da sconosciuti come karaoke e format televisivi con cantanti dilettanti, reality show, etc. Consumiamo “beni di comfort” perché questi si presentano sempre più spesso sotto le mentite spoglie di un “bene di creatività”, ma costano molto meno. Interessante è l’osservazione che in tutti i Paesi del mondo il numero di ore passate davanti alla TV sia inversamente correlato all’indice di felicità, e che nei Paesi occidentali crescano assieme alle ore di lavoro: più si lavora, più tempo si guarda la TV. Persone più stanche per il lavoro tenderanno a consumare falsi “beni relazionali” e “beni pseudo-posizionali”, perché costano meno come tempo e richiedendo un dispendio di energie non comparabile con quello richiesto dalla coltivazione di amicizie autentiche. Ecco perché la società si imbarbarisce, la vita civile ha bisogno di rapporti umani profondi e per questi occorre il tempo che non abbiamo più.
Se è vero che sul piano collettivo l’umanità nel suo insieme si realizza attraverso il lavoro, è anche vero che le singole persone pagano per questa realizzazione collettiva un prezzo elevato in termini di fatica, di espropriazione del proprio tempo, di diminuzione delle libertà e della possibilità di svolgere attività più immediatamente appaganti. Le diverse encicliche Papali pongono molta attenzione al lavoro. Nella Rerum Novarum si ricorda che nella determinazione della giustizia del salario, prima di ogni giudizio di natura economica, entra sempre un elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore alla libera volontà dei contraenti. Nell’enciclica Quadragesimo Anno, il salario deve essere sufficiente non solo al sostentamento ma deve essere tale da permettere più felici condizioni di vita. Nella Populorum Progressio lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini diventa il criterio di equità e di oggettiva moralità del sistema economico mondiale. In sostanza il prezzo di equilibrio non significa necessariamente il “prezzo giusto”, è evidente che un lavoratore occidentale costi più di un lavoratore cinese, il problema non è ridurre i privilegi dei lavoratori occidentali, ma estendere un minimo degli stessi privilegi ai lavoratori del Terzo mondo. Se il progresso ha i suoi costi, non si tratta di regredire in termini di progresso, ma di estenderlo ai popoli che non ne abbiano avuto ancora i benefici, cosa che oltre ad essere eticamente corretta, è anche economicamente vantaggiosa. Tutto l’insegnamento sociale della Chiesa sul lavoro è fondato sulla dignità dell’uomo che lavora, il riconoscimento di questa dignità esige che si fornisca ai lavoratori quell’appoggio di cui hanno bisogno di fronte ad una controparte molto più potente di loro; ma riconoscere la dignità del lavoratore, significa anche ritenerlo abbastanza emancipato e adulto da potersi assumere le proprie responsabilità.
Il nostro paese invecchia rapidamente, molti giovani restano a casa in attesa del posto fisso, le nuove generazioni sembrano impreparate al rapidissimo cambiamento del mercato del lavoro che cerca flessibilità, mobilità e purtroppo manualità, in quanto sono sempre meno le occasioni di posti qualificati e sempre più quelle che richiedano più che una laurea, “un mestiere”.
E’ ovvio che ciascun genitore speri sempre per il proprio figlio un titolo di studio superiore, un posto fisso, magari vicino casa, uno stipendio sicuro, contributi, cassa malattie, ferie, ecc. Poi se per ottenere tutto questo si deve attendere, i giovani restano a casa, e con il passare degli anni, superata la soglia dei trenta anni senza alcuna esperienza lavorativa, rischiano di rimanere tagliati fuori dal mondo del lavoro per tutta la vita. In futuro ormai prossimo, i “posti statali” si ridurranno almeno di un quarto e la stagnazione economica non farà che accelerare la riduzione anche nel privato. Non ci potrà essere un posto a tempo indeterminato per tutti, nè tanto meno si può pensare che tutti riescano ad ottenere un posto impiegatizio.
Ci sono giovani che non hanno alcuna vera occupazione, nessun dovere nè responsabilità, che continuano a condurre un’esistenza senza prospettive per il futuro, vagando in un limbo di eterni peter-pan, in cui pensano di rimanere non si sa fino a quando. D’altronde se nulla corrisponde alle loro aspettative e ai loro sogni, piuttosto che tradirli aspettano il domani che verrà. Non riescono a “trovare”, perché in realtà cercano il “paese delle meraviglie” o le facili scorciatoie che ci propinano i nostri format televisivi. Quelli che restano a casa sono spesso i figli di genitori medio-piccolo borghesi delle grandi città: professionisti o impiegati con buoni stipendi che difficilmente incentivano i ragazzi a rimboccarsi le maniche per rendersi autonomi. L’agiatezza famigliare fatta di casa di proprietà e risparmi, fa in modo che questi ragazzi non abbiano nessun incentivo a fare esperienze lavorative anche se sottopagate, dure o umili. Secondo Confartigianato, nel 2009 una impresa artigiana su quattro ha avuto difficoltà a reperire giovani che volessero imparare un mestiere. Quello che passano i genitori a questi ragazzi: paghetta, auto, vitto e alloggio, vacanze e soprattutto molto tempo libero, non potrebbero ottenerlo lavorando in un call-center o vendendo pizze fuori città con tutti i costi di affitto, utenze, benzina che dovrebbero sostenere; conviene restare a casa e perpetuare la giovinezza. Un domani la casa arriverà, magari in eredità dai genitori o da una vecchia zia, per farsi una famiglia e dei figli ci sarà tempo dopo, del resto l’assenza di assistenza alla terza età fa preferire un figlio a casa, o vicino, a qualunque condizione. Un’intera generazione di ragazzi non sta costruendo una propria vita al di fuori della famiglia, molti non hanno alternativa, ma altri ci restano perché in realtà ci si trovano bene.
In Italia i ragazzi scelgono sempre meno le scuole professionali, preferendogli percorsi universitari che spesso li portano a ritrovarsi senza un lavoro. Le scuole tecniche sono bistrattate dalla maggior parte dei giovani che considerano l’artigianato come un lavoro manuale, di basso profilo, mentre il nostro è il Paese delle piccole e medie imprese, della moda, del turismo, del cibo, dove lavori di per se “artigianali” hanno bisogno di creatività e imprenditorialità.
I giovani si “indignano” contro le banche, ritenendole responsabili non solo della crisi ma anche della loro mancanza di futuro, ma poi non sono disposti a spezzare i meccanismi con cui si autoalimentano, come ridiscutere il loro modello di consumo. La rivendicazione dei giovani d’oggi sembra essere solo quella di ottenere un miglior “posto a tavola” senza mettere in discussione che sulla “tavola” non può essercene per tutti. La battaglia è il superamento della logica dei diritti acquisiti da alcuni a favore dei diritti sostenibili per tutti, e occorre partire subito cominciando dai livelli più elevati e rappresentativi, con mutamenti virtuosi, sostanziali ed immediati, distinguendo i “diritti acquisiti” dai “privilegi acquisiti”. Non bisogna chiedere di diventare una delle tante corporazioni protette, ma di liberare l’Italia dalle troppe “mani-morte” che ne soffocano le potenzialità. Uscire da questa crisi non sarà così difficile a patto che si individuiano i veri nemici da battere e non si disperdano energie e risorse inseguendo falsi miti.
Quando l’economia si blocca e non cresce più, le prospettive delle nuove generazioni diventano incerte, la diseguaglianza si trasforma da speranza in insopportabile ingiustizia. Il progresso dei ricchi non è più percepito come quella crescita della “torta” di cui tutti beneficeranno in futuro, o come un traguardo che tutti impegnandosi potranno un giorno raggiungere, ma diventa solo un privilegio da contrastare in un momento di generale sofferenza. I giovani si “indignano” non per la mancanza di un lavoro qualsiasi, ma sulla mancanza di un lavoro che gli dia il benessere. La questione per loro è chiara: non si risolve togliendo i diritti a chi li aveva conquistati, ma riconoscendo diritti a chi non li abbia, ma per far questo, ci vorrebbero risorse che oggi non ci sono più e che nemmeno il mondo ci vuole più dare comprando i nostri debiti. Il benessere non è un diritto e non può essere conquistato solo tartassando i ricchi se questo servirebbe poi soltanto a creare, non lavoro, ma soltanto retribuzioni, posti fasulli da distribuire a chi non lavora: è un ragionamento da sudditi, non da cittadini.
I giovani non vogliono rischiare, vogliono essere garantiti; non contestano il sistema, ne esigono per diritto una quota; non chiedono liberalizzazioni, l’abolizione degli ordini professionali, flessibilità; pretendono solo la stabilizzazione del precariato, cioè l’assunzione a tempo indeterminato di chiunque abbia mai firmato un contratto in vita sua. Anziché chiedere più libertà, per sé e per tutti, vogliono nuove leggi, nuovi regolamenti, nuove tasse, nuovi vincoli. Anziché rivendicare il merito e chiedere di poterlo far valere, vogliono togliere ai migliori per dare agli inetti. Anziché scommettere sulla propria imprenditorialità, condannano il profitto a spese dei genitori, dalla cui borghese dimora molto raramente si allontanano. Questo è il prodotto di una classe politica che ha permesso una diffusione capillare dell’assistenzialismo, una scuola dequalificata che non sa più né istruire né bocciare, giovani abituati al moderato benessere della famiglia, che scambiano una fortuita combinazione storica con un diritto naturale. Ma i soldi sono finiti, è crollato il comunismo ed ora anche lo Stato sociale, e per la stessa ragione: pubblico e mercato non vanno d’accordo. Oltre una certa soglia, l’intervento legislativo ed economico dello Stato nella vita dei cittadini danneggia il mercato, cioè, in altre parole, ci impoverisce tutti.
Ciò che ci si sente rispondere dai giovani inoccupati è “aspetto” o “cerco” un lavoro, pochi il lavoro provano a “crearlo”. Le nuove generazioni, per motivazioni di vario tipo, si autoescludono preferendo i propri interessi personali alla necessità di diventare economicamente autosufficienti. Bisognerebbe insegnare ai nostri figli l’imprenditorialità, studiare, ma imparare anche un mestiere, mettersi in gioco fin da subito. Oggi l’ereditarietà nel lavoro è diffusissima specie nelle cosiddette professioni protette: farmacisti, commercialisti, avvocati, architetti, ma anche tra gli imprenditori dove, nella maggior parte dei casi, i figli entrano nell’azienda di famiglia. In Italia, come nel resto d’Europa, le aziende a proprietà familiare sono oltre l’80% del totale, ma mentre nel nostro Paese nei due terzi dei casi, l’alta direzione è in mano alla famiglia, in Spagna è un terzo, in Francia e in Germania un quarto, nel Regno Unito un decimo. In Italia si preferisce come direttore “un figlio”, anche se poco preparato o caratterialmente poco adatto, piuttosto che un manager esterno. La classe dirigente Italiana è inoltre più vecchia della media Europea e di fatto con meno capacità innovativa. Il nostro sistema bancario non premia le start-up, le iniziative giovanili senza garanzie, non esistono circuiti finanziari alternativi o contributi statali di lungo periodo per giovani imprenditori, ciò che manca nel nostro Paese è proprio la volontà di assecondare il sistema impresa giovanile.
Bisognerebbe uscire dalla retorica del lavoro a tempo indeterminato, dall’inamovibilità senza se e senza ma. Il precariato è sempre esistito, ma negli ultimi venti anni si è accentuato perché sono cambiate le prospettive di crescita: se il Paese non cresce, si cercano le certezze nel posto fisso, se il Paese fosse dinamico, come lo era ai tempi del boom degli anni sessanta, il lavoro non sarebbe mai mancato, bastava rimboccarsi le maniche.
L’azienda che oggi assuma a tempo indeterminato sa che difficilmente potrà ridurre la sua forza lavoro se sarà necessario. La lotta al precariato “stabilizzato” è una lotta di retroguardia, non si può pensare di trasformare per legge i contratti a tempo determinato in indeterminato, perché a quel punto nessuna azienda ne potrà sostenerne il peso economico. Le aziende non assumerebbero più o se lo facessero, sarà più economico rischiare di farlo “in nero”. L’unico datore di lavoro che può permettersi di non licenziare mai è lo Stato, che di fatto rende il contratto a tempo indeterminato un assicurazione sociale.
La precarietà di per sè non ha connotazioni negative, è così percepita perché esiste chi ha il privilegio lavorativo di essere inamovibile. Il lavoro precario non è solo negativo, è anche sinonimo di possibilità, di occasioni, di creatività e di crescita professionale, mano a mano che migliorano le competenze, ci si considera permanentemente sul mercato alla ricerca di maggiori gratificazioni professionali, di remunerazioni più alte, di benefit, di posizioni di potere, di ruoli a più marcata visibilità sociale; è il nostro sistema Paese che non crea il giusto ambiente scolastico e formativo per vedere al domani con fiducia.
Il mondo del lavoro Italiano contrappone i diritti acquisiti e protetti di chi abbia un lavoro a tempo indeterminato, ai giovani senza tutele che probabilmente non vi entreranno mai alle stesse condizioni. Il nostro è un Paese che non cresce e che si affida ad una classe dirigente che umilia le giovani generazioni. Non si chiede di stabilizzare i contratti precari, ma piuttosto di creare alcuni ammortizzatori sociali tra chi passa da un lavoro a tempo determinato ad un altro. Non potendo sperare in una espansione dei consumi a fronte dell’attuale configurazione della precarietà del lavoro, l’oggetto del contendere non può dunque essere l’alternativa tra lavoro stabile e lavoro flessibile, bensì la qualità del lavoro, l’estensione ed unificazione di un minimo di tutele sociali, il livello di coinvolgimento del lavoro nello sviluppo economico e la condivisione dei suoi risultati. La sfida del futuro è non solo ragionare sul lavoro che manca, ma anche sul lavoro che cambia. Se i risultati della legislazione del lavoro ora penalizzano pesantemente le famiglie, specie quelle monoreddito, questo renderà più difficile e onerosa la formazione delle “nuove” famiglie e la procreazione, e stiamo già vedendo quali ricadute economiche ha lo “sboom” delle nascite in termini di sostentamento delle persone anziane.
Sicuramente i soldi non daranno la felicità, ma un lavoro restituisce la dignità a chiunque abbia il privilegio di averne uno, precario o stabile che sia.
Enrico Giustiniani -
Finanza, etica e religione, Edizioni Marco Valerio
Il costo della vita in un panino: il Big Mac Index
Periodicamente la prestigiosa rivista economica “Economist” pubblica il costo del “Big Mac” di “McDonald’s”, il panino più famoso del mondo, in tutti i paesi dove è diffuso e confronta i prezzi con i cambi ufficiali. Quali differenze nel potere d’acquisto delle diverse monete.
Tutti conoscono MacDonald’s, tutti conoscono il suo panino di carne più famoso il “Big Mac“. Il Big Mac è prodotto con le stesse caratteristiche in ben 120 paesi al mondo.
 L’indice del Big Mac misura quanto costa davvero il panino in ogni parte del mondo. Gli analisti comparano il costo del panino in valuta locale ed il cambio ufficiale con il dollaro. Confrontando il risultato con il costo del Big Mac negli Stati Uniti si vede se la valuta locale è più o meno sottovalutata o sopravvalutata rispetto alla moneta americana.
L’indice del Big Mac misura quanto costa davvero il panino in ogni parte del mondo. Gli analisti comparano il costo del panino in valuta locale ed il cambio ufficiale con il dollaro. Confrontando il risultato con il costo del Big Mac negli Stati Uniti si vede se la valuta locale è più o meno sottovalutata o sopravvalutata rispetto alla moneta americana.
Il prezzo di questo panino è determinato più che dai prodotti che lo compongono: pane, carne, vegetai e salse, dalla manodopera e dal ricarico commerciale. Possiamo assimilare il Big Mac ad un servizio più che ad un bene. Dal confronto dei diversi prezzi per la stessa merce emerge il differente costo del lavoro tenuto conto della produttività dei lavoratori in ogni paese.
L’indice è calcolato dal 1986 dalla prestigiosa rivista americana l’”Economist”.
La filosofia dell’indice del Big Mac si basa su uno dei più vecchi concetti dell’economia: la teoria della parità dei poteri d’acquisto. Il tasso di cambio tra due valute dovrebbe a lungo termine muoversi verso il valore che livella i prezzi di due panieri identici di beni e servizi commerciati in ogni Stato. Ciò che riesco a comprare in un paese con un certo capitale deve essere uguale in ogni altro posto tenendo presente il cambio. Il potere d’acquisto del dollaro americano, dovrebbe essere uguale in ogni paese.
La teoria comunque non è valida in senso assoluto, essendo molte le variabili che entrano nel gioco. Nemmeno nel caso di un panino come il Big Mac sarebbe valida. I prezzi locali possono essere distorti ad esempio dalla barriere commerciali sulla carne, dalle imposte o dai dazi all’importazione sulle differenze dei costi delle strutture commerciali. Tuttavia alcuni studi sull’indice del Big Mac hanno concluso che scommettere sulla più sottovalutata delle valute principali ogni anno è una buona strategia.
L’indice non vuole essere un indicatore delle distorsioni del mercato valutario ma soltanto un indicatore abbastanza preciso, più pratico ed accessibile a tutti, della teoria della parità dei poteri d’acquisto.
Il Big Mac, nei MacDonald’s Americani, costa attualmente 4,93 dollari (al cambio attuale di 1,10 pari a 4,50 euro). Fissando i cambi per le varie valute con il dollaro ed i prezzi del panino nei diversi paesi, vediamo quali risultati otteniamo.
Il Big Mac più caro è in Svizzera, sono necessari l’equivalente di 6,44 dollari in franchi Svizzeri. La moneta Svizzera sarebbe quindi sopravvalutata rispetto alla moneta americana del 30% circa. Il panino più economico è in Venezuela dove costa l’equivalente di 0,66 dollari. La moneta venezuelana è sottovalutata dell’86% rispetto al dollaro.
In generale le monete sottovalutate sono quelle dei paesi in via di sviluppo. Leggendo la classifica dal basso troviamo dopo il Venezuela, la Russia con 1,53 $, l’Ucraina 1,54 $ e via di seguito Sud Africa, Maleysia e India. Sopravvalutate rispetto al dollaro sono solo tre paesi: Norvegia (5,21 $), Svezia (5,23 $) e Svizzera.
Nei paesi dell’area dell’euro, il Big Mac nei McDonald’s costa dai 4,41 $ della Finlandia ai 3,60 $ della Grecia, con un indice medio calcolato nell’area Euro di 4 dollari pari al cambio attuale di 1,10 $/Euro a 3,64 euro. Se negli USA costa 4,93 dollari, secondo l’indice Big Mac il cambio “ottimale” $/Euro dovrebbe essere 1,235 $/Euro quindi attualmente la moneta Americana (cambio a 1,10 $/Euro) sembrerebbe ancora sopravvalutata rispetto all’euro.
In Italia il “big-mac” è calcolato a 4,30 $ pari a a 3,90 euro, quindi il potere d’acquisto è maggiore in Italia che negli USA di circa il 13% anche più rispetto al cambio “potenziale” calcolato dell’indice stesso (4 dollari nell’area Euro).
L’euro comunque non è stato sempre sottovalutato rispetto al dollaro. Il più grande risultato dell’indice del Big Mac è stato quello di pronosticare nel 1999 la svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro americano. Quando la nuova divisa europea è stata lanciata, gli analisti prevedevano che l’euro si sarebbe rivalutato contro il dollaro. L’indice del Big Mac invece nel 1999 indicava che l’euro era significativamente sopravvalutato. Dalla quotazione iniziale di 1,15-1,20 euro contro un dollaro si è arrivati anche a 0,80-0,85 qualche anno dopo.
In generale vedendo l’andamento dell’indice nel corso del tempo, osserviamo che il dollaro americano usualmente sempre sopravvalutato rispetto a quasi tutte le valute. Ora soltanto tre paesi (Norvegia, Svezia e Svizzera) sono più cari della divisa Americana.
Tutte le valute dei paesi emergenti sono fortemente sottovalutate rispetto al dollaro, nei momenti di crisi e di recessione il dollaro è sempre il bene rifugio per eccellenza.
La sopravvivenza del capitalismo è
legata alla sua capacità di trasformazione e nel costante perseguimento del
profitto: Ieri dal plusvalore legato al lavoro, oggi da quello legato
all’informazione, ma domani sopravvivrà a quello legato alla rendita?
Botsuraku, non è un altro nuovo gioco giapponese come il famoso sudoku. Botsuraku significa in giapponese caduta, declino, eclissi. Il termine è stato coniato per identificare la lunga crisi economica di bassa crescita che attanaglia il paese del sol levante dagli inizi degli anni novanta. Un declino che ormai sembra anche impadronirsi dell’Europa ed in particolare del nostro paese. Quello che stiamo vivendo è un periodo duro per le aziende che devono sostenere la concorrenza internazionale, la crisi demografica, la diminuzione dei consumi, l'innovazione tecnologica e la scarsità di finanziamenti. Tutto ciò in un contesto di continua instabilità interna ed esterna. Il nostro modello capitalistico sembra entrare in crisi, incapace di creare un benessere sempre più diffuso. Una crisi le cui ricette economiche per uscirne, sia da destra che da sinistra, delineano scenari e azioni sventolati con toni propagandistici e vaghi, basati su autentici atti di fede espressi in un linguaggio mistico compreso soltanto dai più esperti. Negli anni '80 il Giappone aveva portato a maturazione il capitalismo fino a raggiungere livelli ineguagliati di ricchezza. Dagli anni '90 un lungo ma inesorabile declino. Lo sviluppo economico del Giappone era fondato su basi solide: un apparato industriale avanzato, tecnologicamente concorrenziale ed una forza lavoro ordinata, organizzata e disciplinata. Che cos'è che non ha funzionato? Il capitalismo ha come obiettivo la valorizzazione del capitale tramite un'attività produttiva o commerciale che renda il massimo profitto minimizzando i costi. Senza profitto, l'investimento non avrebbe senso, come conferma la caduta del modello economico comunista. Nell’economia post-moderna non ha più senso parlare di aumento di valore del capitale investito in senso classico. In Giappone la recessione è cominciata quando si è cominciato ad esaurire il ruolo del lavoro nella realizzazione dei beni ed alla contemporanea diminuzione del saggio di profitto rispetto al capitale investito. Per Marx, il saggio di profitto diminuiva all'aumentare della composizione organica del capitale. Restando immutato il grado di sfruttamento del lavoro, il plusvalore viene espresso in un saggio decrescente del profitto. Insieme alla sua materiale entità si accresce pure, anche se non nella stessa proporzione, l’entità del valore del capitale costante e, per conseguenza, del capitale complessivo da impiegare per realizzarlo. Nel lungo periodo, per Marx, accade che il saggio di profitto si riduce, in quanto si riduce la quota di lavoro sul capitale e quindi diminuisce il numero di unità di lavoro applicate alle macchine e poichè il lavoro è l'unico fattore della produzione a produrre plusvalore, si riduce anche il profitto. La legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, per Marx, è la condanna per esaurimento del capitalismo. Poiché il capitalismo ricerca un investimento che crei profitto, questa tendenza lo dovrebbe portare alla sua “naturale” decadenza. Perché la “profezia” di Marx non si è ancora avverata? Perché il progresso tecnologico e l’aumento del commercio internazionale ha permesso di superare le fasi di stasi del capitalismo. Grazie alla globalizzazione e alla tecnologia sono diminuiti i costi di produzione e i costi delle materie prime. Oggi le economie occidentali riescono ancora a rendersi profittevoli in quanto il prezzo dei beni e dei servizi non è più collegato al lavoro necessari per produrli. Si è passati da una società industriale fondata sul lavoro a una società dei servizi fondata sull'informazione. Il profitto dell’attività economica non è più stabilito dall'organizzazione del lavoro, ma dal possesso della conoscenza, della competenza e della capacità scientifica. In una società altamente informatizzata ed in rapido mutamento, è sempre più necessario, per il moderno imprenditore, investire in ricerca. E’ l’informazione aggiuntiva non ancora diffusa, a dare il nuovo plusvalore, è questo l’attuale motore propulsivo al capitalismo occidentale.
Allora perché l’attuale declino? Oggi la produzione deve confrontarsi con gli investimenti finanziari, al cosiddetto capitalismo della rendita. La maggior parte dei capitali hanno già abbandonato da tempo la produzione, tanto che la maggior parte dei movimenti mondiali sono attivati dalla speculazione finanziaria che supera di gran lunga il volume degli scambi reali merce contro denaro, e dal momento che sono i valori monetari a determinare i prezzi, ai quali i produttori venderanno i loro prodotti sui mercati mondiali, gli operatori monetari possono decidere indirettamente su tali variabili nel mondo della produzione. Una sempre crescente parte di plusvalore è ora appannaggio della rendita finanziaria. Negli anni 80, la deregulation del settore finanziario ha aperto la via alla sua globalizzazione. Oggi è il mondo della finanza, fatto di banche, società di intermediazione, hedge funds e fondi pensione a dettare le regole dei mercati, non più la produzione e l’industria. Paradossalmente la nuova minaccia del capitalismo è stata prodotta al suo interno. La rendita non è che l’estremizzazione del profitto, prodotto senza nessun altro fattore che il capitale stesso. Il capitalismo, per mantenere la sua forza propulsiva nell’ideale di diffondere sempre più il benessere, dovrà trovare un nuovo equilibrio tra produzione e rendita. Solo la produzione può garantire beni, lavoro e sviluppo, la rendita potrebbe raggiungere un peso tale da diventare un ostacolo all’obiettivo della ripresa degli investimenti nei settori produttivi e innovativi.
L'eclissi del capitalismo non significa la fine dell'economia, piuttosto una diversa e nuova economia. Questa economia sfrutterà le conoscenze per l'acquisizione di vantaggi commerciali e finanziari. L'informazione diverrà merce e il prodotto più prezioso e ricercato.
Siete bravi al poker online? Sarete degli ottimi speculatori finanziari!
Il filosofo olandese Johan Huizinga, nel suo classico Homo ludens del 1938, considerava il gioco un sistema culturale complesso, una caratteristica universale delle culture umane, un attività non necessaria alla soddisfazione di bisogni pratici e razionali, ma presente in tutte le culture e in tutte le epoche. Le dinamiche del gioco rispecchiano quelle della vita, oltre la componente fortuna, in alcuni per vincere si richiede la cooperazione tra i giocatori come nella canasta, in altri prevale il bluff, l’azzardo e a vincere è uno solo, come nel poker.
La canasta è considerata oggi un gioco da vecchiette, anzi quest’ultime lo hanno abbandonato per il più veloce burraco, ma alla fine degli anni cinquanta, specialmente negli Stati Uniti, la canasta ebbe una diffusione rapidissima. Lo spirito cooperativo del gioco ben si ispirava alla volontà post-guerra della rinascita economica: aiutarsi vicendevolmente dopo le contrapposizioni della guerra, aiutarsi per riuscire. Oggi assistiamo invece ad una netta prevalenza dei giochi legati all’azzardo come il poker o le lotterie istantanee, è la filosofia del “tutto e subito”. Come nel gioco, anche nella finanza c’è l’azzardo che altro non è che la speculazione, non a caso si dice per chi investe in Borsa che “gioca in borsa”.
In effetti poker e finanza sono molto simili: ci sono i soldi, informazioni imperfette, si può scegliere il tavolo da gioco e giocatori come si possono scegliere mercati e società su cui investire. Si possono abbandonare le partite, come si può cambiare investimento: scelte che hanno un costo, per giocare a poker si paga il rake, l’iscrizione al torneo, negli investimenti vi sono le commissioni. In finanza esiste il “parco buoi” per definire gli investitori più sprovveduti, nel poker online esiste il “dead money”, il denaro morto, la maggioranza dei perdenti. In finanza si diversifica, nessuno investirebbe tutto in un singolo titolo, ma anche nel poker, nessuno giocherebbe tutto in un solo torneo. I titoli sono diversi così come le mani di poker sono indipendenti l’una dall’altra. Quello che comunque accomuna di più poker e finanza è proprio il rischio: perdere con un tris vincente è come in finanza investire sul nucleare il giorno prima di Fukushima.
Il Texas Hold’em, la versione del poker online più diffusa, non è più un semplice gioco di carte è forgiare il carattere, dimostrare sangue freddo e determinazione. Bisogna essere veloci nello scegliere e aver la fortuna di indovinare spesso, perché nel poker online come nella finanza moderna, non c’è molto tempo per riflettere o guardare le statistiche. Il trading è in effetti la capacità di tradurre velocemente informazioni soggettive in scelte oggettive.
Oggi non a caso alcune prestigiose finanziarie di Wall Street, hanno cominciato a cercare i broker tra i giocatori più bravi al tavolo verde, spesso sponsorizzano i tornei e ingaggiano i vincitori o inseriscono nelle selezioni del personale sessioni di gioco online in modo che i candidati possano dimostrare la loro resistenza allo stress e la capacità di prendere decisioni sotto pressione e il più velocemente possibile, così come le operazioni di borsa che si concludono spesso in pochi secondi. Le carte da poker sono imprevedibili, così come i rumors di borsa. Chi vince un torneo di poker online, spesso con centinaia di concorrenti, è secondo Brandon Adams, professore di scienze comportamentali e finanza ad Harvard, un “sopravvissuto”, uno che ha tutte le qualità per farcela anche nel mondo della finanza: i pokeristi vincenti ”sanno quando spingere se sono in vantaggio e sanno come evitare la bancarotta, e questa è una combinazione difficile da trovare”.
Viviamo ormai in un mondo senza etica e nella finanza lo si avverte ancor di più. Non esistono crisi economiche ma crisi morali, il rischio dello speculatore come per il pokerista incallito è di finire come Aleksej Ivànovic ne “il giocatore” di Dostoevskij, tramutare il gioco in un'ossessione cieca e irrazionale fino a concentrare tutta la propria energia nel folle sogno di dominare il caso. Per Dostoevskij, tranne in Delitto e castigo, il denaro non è mai frutto di attività produttive: i flussi di ricchezza sono in generale collegati al gioco d’azzardo, al crimine, alla speculazione, o a colpi di fortuna come provvidenziali eredità. Ma mentre il giocatore gioca per se con i suoi denari, i broker e gli operatori di borsa generalmente lo fanno con i capitali degli altri e ciò che possono temere di perdere sono i ricchi “bonus”, i premi sui risultati raggiunti, ma non vivono il terrore di Ivànovic: “… in un attimo mi sono reso conto con terrore cosa significava per me perdere: insieme a quell'oro puntavo tutta la mia vita!”. Terrore che prenderebbe sicuramente ad un piccolo risparmiatore che incautamente abbia affidato le proprie ricchezze a speculatori senza scrupoli, gli stessi ben descritti dalla penna di Italo Calvino in “Se Una Notte D'Inverno Un Viaggiatore”: “Speculare, riflettere: ogni attività del pensiero mi rimanda agli specchi…. Non sanno che ho costruito il mio impero finanziario sullo stesso principio dei caleidoscopi e delle macchine catoptriche, moltiplicando come in un gioco di specchi società senza capitali, ingigantendo crediti, facendo scomparire passivi disastrosi negli angoli morti di prospettive illusorie. Il mio segreto, il segreto delle mie ininterrotte vittorie finanziarie, in un'epoca che ha visto tante crisi e tanti crolli in borsa e bancarotte, è stato sempre questo: non pensavo mai direttamente al denaro, agli affari, ai profitti, ma solo agli angoli di rifrazione che si stabiliscono tra lucide lastre diversamente inclinate.”
Rischio di deflazione mondiale: quali conseguenze, quali ricette per uscirne fuori.
Il filosofo olandese Johan Huizinga, nel suo classico Homo ludens del 1938, considerava il gioco un sistema culturale complesso, una caratteristica universale delle culture umane, un attività non necessaria alla soddisfazione di bisogni pratici e razionali, ma presente in tutte le culture e in tutte le epoche. Le dinamiche del gioco rispecchiano quelle della vita, oltre la componente fortuna, in alcuni per vincere si richiede la cooperazione tra i giocatori come nella canasta, in altri prevale il bluff, l’azzardo e a vincere è uno solo, come nel poker.
Gli Italiani sono fin troppo abituati a parlare di inflazione: l’aumento generalizzato dei prezzi, che probabilmente ignorano il significato opposto, quello di deflazione, ovvero che i prezzi nel corso del tempo diminuiscano.
La grave crisi mondiale ci sta portando da una fase recessiva ad una deflattiva. A prima vista potrebbe anche sembrare anche positiva la diminuzione di tutti i prezzi, ma non è proprio così. Se l’economia è stagnante, le imprese, non riuscendo a vendere a determinati prezzi, cercano di collocarli a prezzi inferiori. Ciò genererà meno ricavi e per ridurre i costi, acquisteranno meno materie prime e servizi, quindi anche meno lavoro, meno salari, meno occupazione. Mentre una moderata inflazione è benefica e fruttuosa per l'impresa, che rivaluta il magazzino ottenendo un surplus di profitto con l’aumento dei prezzi alla fine del ciclo produttivo, in deflazione avviene esattamente l’opposto: i prezzi scendono più rapidamente e le merci, prodotte con costi più alti, genereranno meno guadagni.
La deflazione all’inizio, porterà dei benefici a quei lavoratori che saranno in grado di mantenere l’occupazione con un stipendio fisso o ai pensionati, ma precari, impiegati nella grande industria e coloro senza paracaduti sociali, rischieranno nel breve di non averlo proprio un salario. Uno scenario che non potrà non avere delle ripercussioni anche per le relazioni sindacali per i prossimi rinnovi contrattuali di categoria. Con le aspettative di deflazione, più che ad aumenti salariali, si punterà sugli ammortizzatori sociali, cassa integrazione e sussidi di disoccupazione.
I lavoratori con salari più bassi, anche con scarsa offerta di impiego, potranno sempre fare quei lavori ora scartati e beneficiare comunque della diminuzione dei prezzi anche con salari più contenuti. Ovviamente in una “scala a scendere”, si creeranno inevitabilmente dei problemi concorrenziali tra i lavoratori meno specializzati, come ad esempio gli extracomunitari. Al contrario, i lavoratori con salari medio-alti e più in generale coloro che vivono di rendita, subiranno delle perdite più marcate, sia la riduzione della parte variabile dello stipendio (i premi), spesso sostanziosa, sia per la concorrenza di altri impiegati specializzati in uscita dalle aziende in sofferenza con minori pretese economiche. La riduzione dei tassi d’interesse e dei valori azionari penalizzerà chi vive di rendita, anche gli affitti saranno destinati a diminuire.
La deflazione è una diretta conseguenza della carenza di denaro in fase recessiva. Nonostante tassi pressochè azzerati, la liquidità nel sistema è ancora scarsa, non c’è fiducia, l’accesso al credito è sempre più difficoltoso. La politica monetaria con tassi vicini allo zero diviene inutilizzabile e politiche espansive di spesa pubblica incontrollate possono portare a deficit pubblici abnormi.
Certamente la riduzione selettiva del credito, sfavorisce le imprese indebitate, ma metterà in moto un auspicabile riallineamento tra capitale proprio delle società, di solito esiguo, con quello di terzi. Chi vorrà sopravvivere dovrà mettere i soldi nella propria azienda, la deflazione elimina il vantaggio goduto dal finanziamento a debito rispetto all'auto-finanziamento.
La deflazione in una prima fase ha una sana funzione di perequazione sociale, gravando meno sui gruppi a basso reddito che su quelli ad alto reddito. Favorisce le imprese più efficienti, riduce le rendite speculative e la finanza degli irragionevoli eccessi. ma alla lunga, porta anche ad una generalizzata diminuzione del benessere e al deprezzamento dei servizi sociali, conseguenza della diminuzione delle entrate Statali, che va ad incidere soprattutto sulle classi meno agiate.
La crescita degli ultimi anni e la facilità di contrarre debiti, ha alimentato la formazione di modelli di consumo solo apparentemente necessari: cambiare auto, telefonino, tv, abiti di marca, ristrutturazioni edilizie, ecc. In una fase negativa del ciclo economico, si avverte subito un risveglio “morale” nei consumi con un immediata posticipazione o annullamento delle spese ora ritenute superflue, anche per le attese di ulteriori diminuzioni dei prezzi. Ma così nessuno presta più denaro, le merci non si vendono, non si fanno investimenti e l’occupazione crolla.
L’unico esempio recente di fenomeno deflazionistico è stato quello del Giappone alla inizi degli anni novanta, ma è stato un evento circoscritto ad un singolo paese molto industrializzato, che ne è uscito fuori grazie al traino della generale ripresa mondiale.
Perché siamo arrivati a questa “resa dei conti” mondiale? Molto probabilmente a causa dell’inflazione creditizia. Troppo denaro a buon mercato nei primi anni duemila, ha generato si crescita economica, ma anche un aumento irragionevole di azioni, immobili e della speculazione.
Ora che l’effetto recessivo è conclamato, quale è la ricetta migliore per uscirne fuori? La prima soluzione proposta è stata di utilizzare la “causa” che ha scatenato la recessione: ridurre il costo del denaro e “pompare” ulteriore liquidità nel sistema, ma il mercato non ha reagito in senso positivo. I governi hanno quindi deciso per le politiche espansive di spesa pubblica. Un allentamento dei parametri di Maastricht è auspicabile, ma i paesi più virtuosi hanno margini più ampi dell’Italia, schiacciata già da un debito pubblico accumulato gigantesco, chi continuerà poi a sottoscrivere i titoli di Stato? Anche qui c’è il rischio di sfiducia verso i paesi meno virtuosi come il nostro. Quando si rialzeranno i tassi d’interesse come si pagheranno poi gli interessi?
Alcuni studiosi, come Ludwig von Mises, già nel 1951 in "The free market and its enemies", hanno già vaticinato lo spettro deflattivo: “Non c’è maniera di evitare il collasso finale di una crescita causata dall’espansione creditizia”. La recessione o depressione è l’inevitabile riassetto del sistema produttivo con il quale il mercato liquida gli investimenti improduttivi in eccesso, causati dal boom inflazionistico, e ritorna alla proporzione consumo/investimento preferita dai consumatori. La ripresa arriverà quando questo processo di assestamento sarà terminato. Per Mises, esponente della scuola di pensiero Austriaca estremamente liberale, non si deve intervenire con la spesa pubblica, lo Stato non deve interferire con la recessione, deve impegnarsi solo a raffreddare l’aumento dei salari e dei prezzi e non incentivare gli investimenti improduttivi, quindi sgravi fiscali solo alle imprese che investono. Tutto ciò per permettere al ciclo economico di riprendersi il più velocemente e facilmente possibile.
Etica negli affari e nella finanza. Il duro monito di Pio XI nel 1931 contro l’imperialismo internazionale del denaro, suona ancora di stretta attualità.
Mai come in questi giorni, i recenti scandali finanziari Italiani che hanno coinvolto il delicato ruolo del controllo sul sistema bancario e i pericolosi intrecci tra finanza e sistema politico, hanno riproposto con forza il tema dell’etica e della morale negli affari. Il preoccupante svilupparsi di una finanza immobiliare e mobiliare, basata su spericolate operazioni con capitale di prestito, l’affacciarsi sul panorama finanziario di nuovi “giocatori” con dubbie fortune costruite sulla finanza e triangolazioni su paradisi fiscali, piuttosto che su solide basi industriali e non da ultimo il ruolo spregiudicato di alcuni banchieri che gestiscono denari come se fossero i propri, oltre a dare impulso alla definitiva approvazione alla legge sul risparmio, hanno acceso un dibattito, su cui visione laica aristotelica e cristiana, sembrano trasversalmente convergere nella ricerca di un maggior rigore, che più che essere imposto per legge, deve farsi proprio dalla classe manageriale. Una situazione attuale per certi versi simile a quella della grande depressione del 1929, tanto che nel 1931, Papa Pio XI con l’enciclica Quadragesimo anno, nel sottolineare il ruolo del cristiano nell’economia, condannava con toni espliciti e netti l’imperialismo del denaro, puntando l’indice soprattutto sul ruolo delle banche e sul comportamento dei banchieri che agiscono come veri e propri padroni piuttosto che come manager. Pio XI ritornava sui temi sociali espressi da Leone XIII nel 1891, nell’enciclica Rerum Novarum, riproponendo quelle linee guida di un solidarismo cattolico che verrà ripreso poi da molti movimenti anche non cattolici. Leone XIII da una parte richiamava gli imprenditori e i capitalisti alle loro responsabilità, rimproverando loro egoismo e il tenace attaccamento al denaro, dall'altra esortava le classi operaie a non lasciarsi suggestionare da facili ideologie rivoluzionarie e a non irrigidirsi in una sterile lotta di classe. La posizione della Chiesa contro il capitalismo senza regole e del socialismo è netta. Il cristiano deve cercare una “terza via” per il raggiungimento delle finalità di equità sociale e di solidarismo internazionale a cui tutte le nazioni devono tendere. Linee successivamente sviluppate anche dai successivi pontefici, fino alle puntualizzazioni di Giovanni Paolo II con l’Enciclica Centesimus Annus che riaffermava la centralità sociale e solidale dell’uomo in campo economico: dignità della persona, valore della libertà, funzione positiva della proprietà e dell’iniziativa individuale. Una spiegazione sociale degli avvenimenti economici che però soltanto Pio XI, influenzato sicuramente dalle catastrofiche conseguenze sociali della crisi delle borse del 1929, lega inequivocabilmente anche ai pericolosi intrecci tra denaro e potere, sia nell’ottica degli squilibri interni sia sui nefasti risvolti per l’ordine mondiale. Temi non casuali, visto che vengono significativamente ripresi, due anni dopo nel 1933 nel documento dei Vescovi USA Present Crisis, circa “la concentrazione di potere nelle mani di duri, crudeli e implacabili magnati della finanza”. Una lucida e preveggente analisi quella di Papa Ratti, che va al di là dell’etica cristiana, che induce ad un attenta riflessione ogni uomo del nostro tempo credente o meno. Riportiamo di seguito le parole di Papa Pio XI nella Quadragesimo anno sulla “concentrazione della ricchezza” e “le sue funeste conseguenze”, a cui ogni ulteriore commento e spiegazione ci sembra del tutto superfluo ritenendo le parole del Pontefice come inequivocabilmente essenziali nel fotografare una situazione, che oggi come settantacinque anni fa, ci sembra ancora di stretta attualità. “E in primo luogo ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e piacimento. Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare. Una tale concentrazione di forze e di potere, che è quasi la nota specifica della economia contemporanea, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza. A sua volta poi la concentrazione stessa di ricchezze e di potenza genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si combatte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanitamente per il predominio sul potere politico, per valersi delle sue forze e della sua influenza nelle competizioni economiche; infine si lotta tra gli stessi Stati, o perchè le nazioni adoperano le loro forze e la potenza politica a promuovere i vantaggi economici dei propri cittadini, o perché applicano il potere e le forze economiche a troncare le questioni politiche sorte fra le nazioni. Ultime conseguenze dello spirito individualistico nella vita economica sono poi quelle che voi stessi, venerabili Fratelli e diletti Figli, vedete e deplorate; la libera concorrenza cioè si è da se stessa distrutta; alla libertà del mercato è sottentrata la egemonia economica; alla bramosia del lucro è seguita la sfrenata cupidigia del predominio; e tutta l'economia è così divenuta orribilmente dura, inesorabile, crudele. A ciò si aggiungono i danni gravissimi che sgorgano dalla deplorevole confusione delle ingerenze e servizi propri dell'autorità pubblica con quelli della economia stessa: quale, per citarne uno solo tra i più importanti, l'abbassarsi della dignità dello Stato, che si fa servo e docile strumento delle passioni e ambizione umane, mentre dovrebbe assidersi quale sovrano e arbitro delle cose, libero da ogni passione di partito e intento al solo bene comune e alla giustizia. Nell'ordine poi delle relazioni internazionali, da una stessa fonte sgorgò una doppia corrente: da una parte, il nazionalismo o anche l'imperialismo economico; dall'altra non meno funesto ed esecrabile, l'internazionalismo bancario o imperialismo internazionale del denaro, per cui la patria è dove si sta bene”.
L’etica protestante ha permesso lo sviluppo del capitalismo. Sarà ancora la religione a creare lo sviluppo?
I ricercatori americani Robert Barro e Rachel McCleary hanno condotto una ricerca empirica sui fattori determinanti di sviluppo economico e l'influenza della religione. La ricerca, attraverso un esteso campionamento statistico, arriva a determinare una correlazione diretta tra i due fenomeni. Lo sviluppo tende ad aumentare se confrontato alla religiosità personale, ma tende a diminuire se confrontato alla frequentazione dei luoghi di culto. L’accrescimento economico di una determinata comunità dipende più dalla religione intesa come valore personale piuttosto che come frequentazione attiva.
Quasi un secolo fa, il sociologo Max Weber teorizzò che fu la riforma protestante-calvinista, attraverso l’organizzazione della propria vita orientata al lavoro ed al guadagno, ad innescare l'avvento del capitalismo moderno, non più inteso come semplice accumulo della ricchezza ma nel continuo suo accrescimento. Dio domina i destini dell’uomo, e a quest’ultimo non resta che attenersi alle regole morali stabilite per garantirsi la vita eterna. Sarebbe quindi la ricerca di una ricompensa eterna nell’aldilà a influenzare l’attività professionale. La ricerca di Barro-McCleary sostiene questa teoria con le statistiche. In media nei paesi dove gli intervistati si dichiaravano credenti, ancorché non praticanti sono associati con i buoni atteggiamenti economici. Un risultato giunto dopo aver analizzato i dati raccolti in cinquantanove paesi dal 1981 al 1999. La religione influenza positivamente lo sviluppo poiché insegna valori come: l'onestà, l'imparzialità, la fiducia e l'integrità che possono promuovere lo sviluppo economico. Questo è vero fino a quando il credo personale non si traduce in una più alta frequentazione dei luoghi di culto. Barro e McCleary riscontrano che un alto livello di reddito pro-capite è associato negativamente alla domanda di servizi religiosi. Questo avviene per due ragioni: la superstizione, ovvero l’affidamento al soprannaturale tipica di ogni credo religioso, tende a perdere importanza con il diffondersi dell'istruzione e dell'atteggiamento scientifico, ambedue tipici dello sviluppo economico. In secondo luogo, il crescere della prosperità implica solitamente anche il ridimensionamento del ruolo delle organizzazioni religiose nei processi decisionali, politici e legislativi di una società. Questo è infatti vero nei paesi ricchi come quelli del nord Europa che associano ad un altro reddito pro capite una bassa religiosità, con la sola evidente eccezione degli Stati Uniti. Per spiegare la bassa religiosità di Paesi come la Spagna e la Grecia, invece, si deve riflettere sul ruolo di monopolista svolto dalla Chiesa, cattolica e ortodossa, in questi Paesi. La ricerca dei due studiosi evidenzia che dove c’è maggiore concorrenza tra le diverse religioni, tende ad aumentare lo sviluppo. Anche qui abbiamo delle eccezioni, come l’Italia ad esempio, dove la posizione di favore rispetto alle altre Chiese, associata alla concessione di sussidi statali, determina una religiosità ancora relativamente elevata rispetto ad altri Paesi al nostro stesso livello di sviluppo e con una simile struttura confessionale.
Un punto ci dovrebbe far riflettere. Quando Weber ha sostenuto, le sue tesi sui rapporti tra religione e sviluppo economico lo fece in un ambito culturale modellato sulla cristianità protestante, senza controprove statistiche. Weber nella prefazione al suo lavoro affermava esplicitamente la propria ignoranza in tema di religioni non cristiane. Se in un determinato momento storico la religione si è rilevata come indispensabile spunto per la nascita del capitalismo moderno in occidente, è pensabile che questo altrove abbia esercitato la medesima influenza o per gli stessi motivi l’abbia impedito.
Oggi l’occidente cristiano e ricco, è molto più interessato alla qualità della vita e alla perequazione sociale che allo sviluppo economico, al contrario si stanno enormemente sviluppando le economie di realtà “non cristiane” come la Cina e l’India. Dall’analisi del confucianesimo, del buddismo e dell’induismo scopriremo se ancora una volta sarà l’etica religiosa a dettare i nuovi imperativi morali di sviluppo.
Un altro interessante considerazione dagli studi di Barro e McCleary, viene dall’osservazione che in alcuni paesi, specie Islamici, dove c’è una forte credo religioso nell’ultraterreno come Bangladesh, Malesia, Pakistan e Turchia il loro prodotto interno lordo è del 0,5% superiore alla media. Nei paesi musulmani infatti il credo nell’ultraterreno è mediamente più sentito che nella cristianità. Questo sarebbe un interessante filone di sviluppo, soprattutto in un ottica di ricerca etica. L’Islam esorta gli uomini a spendere il loro denaro nella via di Dio, anche se ciò dovesse condurre a disporre di ogni proprietà. Non vi è dubbio che l’Islam avrebbe incoraggiato i risultati lodevoli prodotti dal capitalismo nella sua prima fase. Ma l’Islam non avrebbe lasciato il capitalismo privo di legislazione atta a disciplinarlo ed a impedire ogni sfruttamento che potesse risultare dalla malvagia volontà dei datori di lavoro o dalla natura stessa del capitale.
I giovani sognano il posto fisso, perchè l’imprenditoria non si insegna a scuola.
Il mondo del lavoro non è più in grado più di assorbire le aspettative e i profili professionali dei giovani. Viviamo un momento dove l’”indeterminato” non più il contratto, ma il futuro lavorativo. L’esigenza di sicurezza e stabilità prevale sulla domanda di autonomia e qualità. Così il lavoro in proprio e l'attività da libero professionista, che ha accompagnato la lunga stagione del boom economico degli anni sessanta, oggi risulta meno attraente, mentre è cresciuta la preferenza per il "posto fisso" e vicino casa. E’ diventata più importante la sicurezza che la qualità del lavoro, a qualsiasi stipendio. La nostra economia difficilmente produce occupazione di qualità, ma quando la cerca, non trova profili idonei. A titoli di studio qualitativamente sempre meno competitivi, si aggiungono meccanismi di formazione e di selezione della classe dirigente ancora caratterizzati da una bassa capacità di ricambio e da una pronunciata longevità, tanto che da tempo alla meritocrazia si è sostituito il nepotismo. I giovani non vogliono declassarsi a lavori umili, preferendo attendere piuttosto che inserirsi subito nel mondo del lavoro. L’occupazione resta dinamica per i lavori più manuali a bassa scolarità, che vengono occupati dagli immigrati, gli Italiani restano a casa cercando il “posto fisso”, impiegatizio.
Un individuo protetto, garantito e quindi per certi versi spersonalizzato conduce, parafrasando l’economista ultraliberale Sergio Ricossa, alla stazionarietà e alla rassegnazione nella povertà. Il lavoro è oggi scarso, ma si insegue la sicurezza nella povertà, piuttosto che adeguarsi alla continua mutevolezza del mondo capitalista. Ecco perché si accusa il sindacato di fare una lotta di retroguardia: chi ha il lavoro sicuro viene difeso, chi è fuori resta escluso, c’è la percezione che il lavoro non è più visto come fattore di produzione, ma come mezzo per garantire socialmente uno stipendio a chi ce l’ha già. Ma d’altro canto non basta togliere vincoli ai datori di lavoro e invogliarli a produrre, come non basta la retorica sindacale del diritto al lavoro, esiste un malessere sociale più strutturale; perché i giovani dopo anni di studi e sacrifici, sperano di trovare in un lavoro sicuro anche se poco attraente? Un lavoro “apparente” come lo chiamava Adriano Olivetti negli anni cinquanta: “Quello che dà legittimazione sociale attraverso il posto, lo stipendio, le assicurazioni e offre la possibilità di stare sul lavoro otto ore potendo starcene quattro”. La tecnologia dagli anni novanta, sta facendo fuori centinaia di posti di lavoro e quelli che vengono mantenuti diventano una sorta di welfare che rimedia all’espulsione della forza lavoro. Quando il ciclo dei consumi e degli investimenti privati si inceppava per Keynes era fondamentale l’intervento statale, il “paradosso delle buche”: basta dare una pala e pagare i lavoratori per scavare buche e poi riempirle, con i salari avrebbero sostenuto i consumi e quindi aiutato la crescita della domanda. Il lavoro “inutile” serve perché è morale avere salario in cambio di qualcosa “guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte” come sentenzia la Genesi. E’ la “sindrome della burocrazia”, parafrasando un altro famoso economista liberal, John Kenneth Galbraith: uno staff numeroso, ancorchè inutile è simbolo di potere. Più si hanno sottoposti più si è importanti.
In Italia le inefficienze del pubblico impiego e i vincoli normativi ci pongono orami costantemente negli ultimi posti delle classifiche Ocse per le opportunità di creare business. Secondo dati della Banca Mondiale nel rapporto “doing business”, in Italia per aprire un attività servono nove pratiche e almeno tredici giorni per richiederle. Siamo ancora 45 posto nel mondo (eravamo al 56 nel 2014) ma ancora molto indietro rispetto agli altri principali Paesi Europei. Perché non si riesce ad invertire la tendenza? Ovvio, il posto pubblico, favorisce e radica il consenso politico e favorisce l’acquiescenza sociale. Il tutto fino a quando il bilancio dello Stato ce lo permetterà. Lo Stato è diventato il posto “apparente” per definizione, da quanto lo stesso si è assunto il ruolo di assorbire la manodopera non appetibile dal privato. L'impresa per non delocalizzare, risparmia lavoro per essere competitiva e scarica sullo Stato gli oneri sociali dell’occupazione.
Forse un tempo il burocrate non era pienamente consapevole della sua inefficienza o della sovrabbondanza del personale, ma per la prima volta assistiamo ad una maggioranza giovanile che vede questo come un obiettivo di vita. Se si cerca un lavoro “non voluto”, inutile, si perde il senso della realtà. Non è efficiente un produttore di pesche quando sa che verrà pagato per distruggerle in sopraproduzione, non lo sarà nemmeno un giovane neoburocrate che spera solo di intascasse un misero stipendio senza fatica e vicino casa.
Perché i giovani non sono attratti dall’imprenditorialità? Esiste una valida alternativa al posto fisso? L’imprenditore non è colui che assume solo il rischio di impresa, ne è un fattore produttivo che si può acquistare sul mercato. La grande verità è che l’imprenditoria non si insegna a scuola e come il coraggio di Don Abbondio di Manzoniana memoria: “se uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può dare”, secondo la grande tradizione economica liberale della scuola Austriaca di Von Mises, «per riuscire negli affari all’uomo non occorre il diploma di scuola commerciale. Queste scuole preparano subalterni per lavori di routine, non imprenditori. L’imprenditore non può essere ‘preparato’. Si diventa imprenditori cogliendo l’opportunità di colmare una lacuna». Ciò che impedisce l’imprenditorialità, non è il titolo di studio, ma sono le restrizioni legali, istituzionali, burocratiche. Il liberale non pensa che l’imprenditorialità sia un fenomeno borghese, tutt’altro, anche le persone più umili, che detengono una minore importanza sociale, o minore scolarità, possiedono, in modo esclusivo, piccole porzioni o parti di conoscenza e di informazione che possono avere un valore rilevante nell’ambito delle dinamiche sociali. Ne è un esempio la dinamica imprenditorialità degli immigrati nel piccolo commercio al dettaglio.
Purtroppo in Italia, il sistema finanziario non da credito alle idee e quindi è scarsamente probabile che esca fuori un Bill Gates finanziando un sistema operativo costruito nel garage di casa. L'approccio della scuola Austriaca è l'unico che ha il proprio focus sulla capacità imprenditoriale dell'essere umano. Imprenditore è sinonimo di innovatore, non deve avere particolari doti intellettuali, non è né un inventore né un tecnico, è un pratico che coglie l’opportunità fuori dal consueto.
Spesso si pensa che incentivi statali generalizzati possano aiutare l’imprenditoria, ma si commetterebbe lo stesso errore degli economisti classici se si pensasse che tutti possono essere imprenditori, non è detto che tutte le idee possano tramutarsi in utili. Il profitto non è la semplice remunerazione delle capacità esecutive e organizzative, capacità tipiche del manager, anziché dell'imprenditore. Né è la semplice remunerazione del rischio, che riguarda invece i fattori produttivi come il capitale, che potrebbe andare perduto o essere investito in attività meno incerte, o come il lavoro, infatti si può preferire, come in effetti accade, di specializzarsi e laurearsi e restare anche disoccupati per periodi più o meno lunghi, invece che intraprendere un attività.
Il profitto remunera l'abilità dell'imprenditore nel percepire gli errori altrui e dunque le opportunità di miglioramento, ancor prima che il manager organizzi le risorse per trasformare l'occasione imprenditoriale in realtà d'azienda. L'imprenditore può essere anche privo di mezzi di produzione, poiché l'atto imprenditoriale non consiste nell'organizzare e attivare le risorse, bensì nell'individuare le opportunità. Cosa deve fare lo Stato allora? Più che incentivi a pioggia, bisognerebbe facilitare l’accesso ai mercati dei beni, dei fattori, delle tecnologie. La scuola deve essere più responsabile, non deve fornire solo manager o impiegati, ma anche persone capaci di creare situazioni nuove, in poche parole: imprenditori. Le parti sociali d’altro canto devono fare in modo che la maggioranza protetta ceda parte dei suoi vantaggi a favore della minoranza emarginata. Questo significa: diminuzione dell'orario di lavoro in cambio di nuova occupazione, collegamento tra retribuzione e produttività, mobilità e soprattutto nuove regole distributive se non vogliamo che si approfondisca la distanza tra cittadini protetti ed esclusi.
Scritta ieri: la “rivoluzione liberale” per i giovani. Le radice liberali del pensiero socialista. Il pensiero rivoluzionario di Piero Gobetti, un giovane da far riscoprire ai giovani.
Il socialismo e liberalismo. “Tutti e due sono figli dell’industrialismo, sono fenomeni di lotta politica. Se si risale al marxismo e si fa una critica del bagaglio economico collettivista si finisce per trovare un terreno comune.”
“Il socialismo è il simbolo in nome del quale combatte da anni innumerevoli il popolo per la sua redenzione; è la più attiva delle idee che abbiano operato nella realtà come impulso all’autonomia, è uno dei più grandi fattori di liberazione e di liberalismo nel mondo moderno”
In un momento di transizione politica per alcuni aspetti simile alla situazione che precedette l’ascesa del fascismo: ai partiti tradizionali, si sono affermati nuovi partiti, allora il popolare e il fascista, oggi Forza Italia, Alleanza Nazionale e la Lega. Al partito comunista i democratici della sinistra, ai socialdemocratici la margherita. Sia allora che oggi, le sinistre sembrano sbandate e alla ricerca di un nuovo corso. Piero Gobetti in soli 25 anni di vita, con il suo ardore giovanile ha tracciato un segno indelebile nel pensiero liberale e socialista moderno.
L’ideale di liberalismo non è un concetto riservato ad una ristretta cerchia di vecchi borghesi ma rimane ancora un pensiero vivo e giovane da far riscoprire ai giovani. Una vera “rivoluzione liberale”, come il titolo della sua rivista che fondò nel 1922 a soli ventuno anni. Chiede sempre ai suoi collaboratori serietà ed ardore. Intende la politica come missione spirituale e non come un meccanico calcolo di potere.
Lo stesso Gobetti nell’avviso ai lettori nel primo numero “si propone di formare una classe politica che abbia chiara coscienza delle sue tradizioni storiche e delle esigenze sociali nascenti dalla partecipazione del popolo alla vita dello Stato”.
Gobetti, è liberale e socialista, riconosce il valore della fabbrica che "educa al senso della dipendenza e della coordinazione sociale, ma non spegne le forze di ribellione, anzi le cementa in una volontà organica di libertà". I lavoratori a reddito fisso e gli imprenditori non speculatori e non protezionisti hanno interesse comuni: l'equità fiscale, innanzi tutto, che è un problema di eguaglianza e anche un aspetto del libero mercato, se si volesse tentare di farlo esistere almeno in parte; e la lotta alla corruzione e alle clientele politico-affaristiche, che è un problema di giustizia.
Gobetti è un fenomenale organizzatore di cultura, di ideali, di giovani, ma soprattutto di rinnovamento morale e ideale, di un nuovo Risorgimento. Nell’attuale momento di deprimente stagnazione e di pericolose fughe verso idee che pensavamo ormai morte, Gobetti appare quanto mai attuale.
Il pensiero Gobettiano ha avuto un posto di rilievo nella nuova visione socialista portata avanti anche da Bettino Craxi nel “nuovo corso” del socialismo riformista. “Tutti i partiti, le correnti e le scuole che si sono richiamate al socialismo, si sono poste in antagonismo al capitalismo, ma ciò non è quasi mai stato sufficiente ad eliminare divisioni e contrapposizioni. I modelli di società che indicavano come alternativa alla società capitalistica erano spesso antitetici”. Troviamo nel pensiero di Gobetti lo stessa percezione successiva di Craxi di divaricazione tra società socialista e la società comunista. “dal lato il comunismo che vuole la soppressione del mercato, la statalizzazione integrale della società e la cancellazione di ogni traccia di individualismo, dall’altra il socialismo, che progetta di instaurare il controllo sociale dell’economia e lavora per il potenziamento della società rispetto allo Stato e per il pieno sviluppo della personalità individuale.”
E fin dalla prima pagina della sua rivoluzione liberale fa una dichiarazione fulminante e valida più che mai oggi: "Il contrasto vero dei tempi nuovi come delle vecchie tradizioni non è tra dittatura e libertà, ma tra libertà e unanimità".
In Lettera a Parigi, articolo scritto ad un amico immaginario nell’ottobre 1925 Gobetti lascia un testamento politico e morale che sembra scritto per molti aspetti ai giorni nostri: ”Ma esiste in Italia un gruppo di uomini nei partiti e fuori dai partiti che non ha ceduto e non cederà. (…) La loro rettilinea protesta, salva i quadri dell’Italia politica futura. Nessuno di essi diventerà ministro o grande burocrate (…). Tra le illusioni universali il cervello di questi uomini funziona, la folla e il successo non hanno prestigio sulla loro volontà di dirittura, sul loro animo non servile. Se tra gli antifascisti ci saranno dei disertori, se molti oppositori troveranno più comodo combattere il fascismo aderendovi, l’antifascismo che qui ti ho descritto non ne sarà minimamente sorpreso”.
Il telelavoro per preservare i piccoli centri dallo spopolamento e migliorare la qualità della vita
Dall’esperienza di alcuni paesi europei a quella di piccoli centri montani dell’Appennino Emiliano, i centri di telelavoro introducono in aeree disagiate, in ritardo di sviluppo o soggette a spopolamento e pendolarismo, nuove opportunità di sviluppo economico e di occupazione locale.
In Svezia questi centri sono ormai una realtà nelle piccole isole, quasi disabitate intorno a Stoccolma, dove a Sandhamn, Arholma, Orno, alcuni uffici pubblici hanno delegato in outsourcing alcuni call center che ora servono tutta la capitale.
Programmi non solo pubblici ma anche finanziati dalle stesse imprese. Nell'arcipelago delle isole Shetland in Scozia, il gruppo Leader ha varato un progetto di telematica rurale ("telecroft"): si tratta di introdurre le nuove tecnologie dell'informazione nelle isole più periferiche, attuando piccoli centri computerizzati che permetteranno di migliorare i servizi, creare nuove opportunità occupazionali (segreteria, burotica, contabilità, formazione) nonché di realizzare il lavoro di catalogazione delle collezioni del Museo delle Shetland.
Esempi analoghi più su larga scala, in India, dove importanti multinazionali informatiche e finanziarie americane utilizzano largamente la manodopera locale altamente secolarizzata ed a basso costo per i loro call-center ed help desk che servono gli utenti dei loro servizi in tutto il mondo.
Tecnologia non solo al servizio dei paesi ricchi. I sistemi via satellite alimentati con apparecchi fotovoltaici, con Internet a larga banda, telefonia cellulare e canali tv, portano il futuro alle comunità residenti in aree isolate e depresse del sud del mondo, prive di infrastrutture elettriche e telefoniche.
In un mondo sempre più globale e telematico, la localizzazione fisica del lavoro assume un ruolo relativo rispetto alla sua finalità. Le aziende puntano dove possono trovare risorse qualifiche e tecnologia a buon mercato indipendentemente dalla loro localizzazione. Questo può tramutarsi in un opportunità per le comunità Italiane più disagiate, grazie anche a fondi disposti da alcune regioni o quelli del Fondo di sviluppo Europeo come ad esempio il progetto Leonardo da Vinci per l’attuazione della politica di formazione professionale.
L'Italia è l'unico paese del mondo ove esiste una legge che favorisce il telelavoro dei dipendenti pubblici, con la “Bassanini ter” che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, ai fini di una più efficiente organizzazione sul territorio di forme di lavoro a distanza.
Oltre a frenare il saldo demografico dei piccoli comuni il telelavoro, può rappresentare un opportunità di ripopolamento in zone più vivibili con a disposizione immobili da locale o da affittare a prezzi più abbordabili.
Le nuove tecnologie possono consentire l’attuazione di nuove iniziative che possano coinvolgere direttamente manodopera locale scolarizzata che altrimenti sarebbe costretta ad allontanarsi dai piccoli centri per cercare lavoro altrove.
L’allestimento di un centro di telelavoro presso i piccoli comuni permetterebbe di offrire sia opportunità formative ai cittadini, sia servizi alle Pubbliche amministrazioni come: la gestione di numeri verdi, call-center, telemarketing, teleassistenza, gestione guasti e reclami delle aziende municipalizzate. Servizi che, su più ampia scala, possono essere forniti anche ad imprese private, indipendentemente dalla loro localizzazione, come: customer care e service, informazioni su prodotti, informazioni sui servizi e sugli orari, help desk, rapporti con i fornitori e clienti, prenotazioni, sportello di segreteria, videoconferenze, grafica.
Il telecentro si basa sulla possibilità di ospitare, anche su piccole superfici delocalizzate, una “Agorà multimediale”, un luogo di scambio e socialità culturale e professionale dove gli utenti possano scolarizzarsi informaticamente, migliorare le loro conoscenze attraverso l’uso delle risorse multimediali, navigare in internet o nella rete civica, consultare la posta elettronica. Inoltre l’investimento iniziale può essere recuperato attraverso l’affitto parziale dei locali del telecentro e delle infrastrutture informatiche sia a lavoratori già occupati e che desiderano entrare parzialmente o totalmente nel circuito del telelavoro sia a datori di lavoro anche pubblici della regione. Il telecentro diventa un mezzo che oltre ad agevolare lo sviluppo organizzativo e incentiva l’iniziativa produttiva del tessuto economico come start-up di nuove imprese tecnologiche.
Un ulteriore evoluzione che coniuga innovazione con innalzamento della qualità della vita è il “telecottage” che sta trovando spazio nei paesi scandinavi. Si tratta di un’intera comunità attrezzata per il telelavoro, in cui ogni casa è connessa via cavo e collegata, tramite una rete interna, alla rete del villaggio e, tramite una larga banda, al resto del mondo. Gruppi di persone che, sul piano locale perseguono obiettivi di ordine sociale ed economico più ampi. In particolare: il miglioramento dell'integrazione sociale delle comunità locali e l’incoraggiamento di una "economia di solidarietà" 1'accesso delle comunità locali alle tecnologie dell'informazione; la fornitura di servizi basati sulle tecnologie dell'informazione alle imprese locali. L'organizzazione di corsi di formazione per 1'uso delle tecnologie di informazione; lo stimolo alla creazione di nuove imprese; la creazione di opportunità di lavoro a livello locale; la creazione di asili nido. Questa maniera di lavorare risulta gradita alle persone che desiderano coniugare uno stile di vita rurale con l’uso della tecnologia.
Un "villaggio di telelavoro" è stato sviluppato vicino a Crickhowell nel Galles, e l'idea viene dibattuta in altre aree ambientalmente attraenti, come le "highlands" e le isole della Scozia.
La politica attiva per il lavoro in Italia deve compiere un salto di qualità. Si tratta di investire nelle moderne infrastrutture telematiche, nelle nuove tecnologie informatiche, innanzitutto nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Paese ancora ricche di attrattiva per la loro vivibilità.
La relativa arretratezza del sud d'Italia, ricco però di capitale umano ed ambientale, può, se corretta da una adeguata politica, tramutarsi in una risorsa per l'innovazione, in una risorsa per la società dell'informazione.
La teoria della “raccomandazione”
La differenza di stipendio tra lavoratori a parità di mansioni è dovuta in parte non a che cosa si conosce ma a chi si conosce. Questo in sintesi è il risultato di un modello matematico elaborato dal premio nobel per l’economia Kenneth Arrow, professore emerito alla Stanford University e Ron Borzekowski ricercatore della Federal Reserve Statunitense, presentato nell’agosto di questo anno (un estratto su internet all’indirizzo: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200441/200441pap.pdf).
Sembrerebbe dunque che è matematicamente dimostrabile che la “raccomandazione”, la “spintarella” conta per migliorare il proprio salario ed avere più possibilità d’impiego.
Arrow aveva vinto il nobel con il “teorema dell'impossibilità”. Tutti i meccanismi di decisione sono imperfetti. L'individuo stesso è un input di tutti i suoi canali di informazione e, se ha senso esprimersi in termini quantitativi, è l'input più importante.
Arrow afferma che caratteristiche come intelligenza, educazione, esperienza ed età spiegano soltanto la metà delle differenze tra gli stipendi di persone che hanno le stesse qualifiche. Gli stipendi non rispondono alle leggi della domanda e dell’offerta ma sono correlabili all’offerta competitiva delle aziende. Studiando soprattutto l’andamento dei salari dei bianchi e gli afroamericani, nelle mansioni più basse è riscontrabile che più si hanno “conoscenze“ nel mondo del lavoro più si ha la possibilità di guadagnare stipendi più alti. Questo è l’effetto del “network”.
Negli Stati Uniti circa il 50% dei posti di lavoro è trovato attraverso canali informali primi tra tutti la famiglie e gli amici. Le aziende cercano di non fare assunzioni basate solamente sui curriculum, ma cercano di avere quelle che un tempo si chiamavano referenze. Del resto per alcune mansioni, come le babysitter ad esempio, sono più importanti le referenze che i titoli certificabili. Nessuna mamma affiderebbe i propri figli ad una persona preparata ma non provata sul campo.
La quantificazione di queste “conoscenze”, non basate sui dati empirici ma su osservazioni reali, arriverebbe a calcolare che una persona con una sola conoscenza potrebbe guadagnare $19.570 all'anno. Al contrario, una persona con cinque conoscenze in altrettante aziende potrebbe guadagnare fino a $30.410. Arrow e Borzekowski concludono che la differenza nel numero di legami può indurre ad una notevole diseguaglianza nelle retribuzioni spiegando il 15 – 20% dei casi in cui tale variazione a parità di mansioni ed anzianità sarebbe ingiustificata.
Come prima conseguenza di questa verità scientifica al fine di livellare le diseguaglianza sarebbe necessario che i lavoratori aumentassero i loro contatti in azienda attraverso internet ad esempio o attraverso mediatori sociali capaci di moltiplicare le possibilità di impiego per i singoli lavoratori.
Fortunatamente questo modello non funzionerebbe con i profili professionali più elevati. Un laureato ad Harvard non ha bisogno del network per avere possibilità di guadagnare di più rispetto ad un collega che non si laureato in un prestigioso ateneo.
Abituati a pensare come indispensabile “avere delle conoscenze” per un “buon posto” o semplicemente per un “posto” di lavoro il risultato ancorchè scientifico di questa teoria per noi Italiani sembrerebbe piuttosto scontato. Le aziende preferiscono ancora la conoscenza diretta, magari partendo proprio da un buon Curriculum. Secondo Excelsior 2004, l'indagine annuale di Unioncamere e del Ministero del Lavoro, per il 62% delle imprese (su circa 100mila interpellate) è fondamentale la conoscenza diretta del candidato, per un 26% conta ancora la segnalazione di conoscenti e fornitori. Quindi una buona preparazione ma se qualcuno garantisce l’affidabilità è anche meglio. Il ruolo fiduciario è ancora determinante per il 64,5% delle piccole imprese, con meno di 10 dipendenti. Ma in quelle più grandi, l'incidenza è minore: si va da un massimo del 47,7% per le imprese con 10-49 dipendenti a un minimo del 21,6% per le imprese con oltre 500 dipendenti. Sempre dalla stessa ricerca evidenzia comunque un dato che confuterebbe la teoria dei nostri studiosi Americani: solo il 0,3% delle società interpellate utilizza internet, il mezzo che permetterebbe più facilmente di moltiplicare i propri contatti, per le proprie ricerche di lavoro.
Del resto far leva sulle persone importanti per avere ottenere ciò che si vuole è vecchio come il mondo. Anche nel Vangelo di Marco, gli apostoli Giacomo e Giovanni chiedono a Cristo: "Vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo... Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra." Gesù, fortunatamente, lungi dal mostrare severità alcuna, trova le risposte più congeniali alla presente richiesta, replica affermando l'assurdità di una simile pretesa: "Voi non sapete quello che chiedete!... non sta a me concederlo".
La patrimoniale per le Società. La patrimoniale è prima di tutto uno strumento efficiente, non estranea al pensiero liberista. Applicata nel giusto modo permette di perequare il gettito tributario.
Potrebbe sembrare una provocazione di sinistra parlare di patrimoniale, ma nella storia, non pochi furono i fautori liberali a chiederne l’introduzione. L’imposta patrimoniale è prima di tutto un meccanismo di efficienza, più che di equità. In molti paesi la proliferazione degli incentivi fiscali ha prodotto artificiose strutture societarie spesso costruite per mere esigenze di diminuzione del carico fiscale. La distorsione del reddito, dovuta sia da interazioni elusive intenzionali, sia da benefici ed esenzioni di legge, ha indotto alcune autorità fiscali nazionali a prendere in seria considerazione l’introduzione di un imposta patrimoniale societaria in alternativa, o in aggiunta, alle attuale imposte esistenti. La patrimoniale societaria, la “Minimum Assets Tax” (Mat), viene già applicata in alcuni paesi Sudamericani ed in Olanda. L’imposta va a colpire, con una percentuale molto bassa, il valore dell’attivo (“assets”) delle imprese: immobili, titoli, cassa, indipendentemente dal profitto generato, nettando o meno i debiti dalla base imponibile. La Mat si pagherebbe a prescindere dal profitto generato, differenziando l’aliquota per ampi intervalli di valore patrimoniale e per settori produttivi. Potrebbe anche essere introdotta come un corrispettivo minimo d’imposta prefissato che le società potrebbero compensare poi, negli anni successivi, in base alla reale imposizione sui profitti con un meccanismo di credito d’imposta. Si avrebbe per il fisco un gettito quasi costante indipendentemente dalla fasi congiunturali, permettendo di avvicinare il gettito “reale” a quello “ideale”, oltre a recuperare gettito eluso dagli effetti indesiderabili derivanti dall'abuso nel ricorso ad esenzioni, benefici ed agevolazioni agli investimenti, che molto spesso nascondono forme di vera e propria evasione fiscale.
Le imposte basate su sistemi oggettivi, come le patrimoniali, sono molto diffuse soprattutto negli Stati Uniti e Giappone. In Italia ne sono un esempio i “studi di settore”, meccanismi induttivi per la fissazione di una certa base imponibile in base a dei parametri oggettivi: fatturato, dimensioni, numero di impiegati, ecc., a cui le aziende tendono ad allinearsi per restare al di fuori di possibili accertamenti da parte dell’Amministrazione fiscale. A differenza dei meccanismi fiscali “irrifiutabili” da parte del contribuente, come le patrimoniali o l’IMU, i meccanismi di calcolo degli “studi di settore” o gli accertamenti induttivi, in caso di mancanza di scritture contabili o evasione totale, appartengono ai meccanismi presuntivi a cui il contribuente può sempre opporsi od argomentare importi diversi.
Le imposte patrimoniali, oltre che la certezza del gettito, permettono una maggiore semplificazione amministrativa sia nel calcolo che nell’accertamento. Molte società, pur presentando valori ingenti dei propri attivi, dichiarano un valore aggiunto molto basso e perdite d’esercizio, anche per effetto dell’elevato indebitamento rispetto al capitale proprio. Questo induce a suggerire l’introduzione di un qualche vincolo tra il valore degli attivi e il valore aggiunto dichiarato, introducendo una “minimum asset tax”. Vista come misura complementare, compensabile come credito d’imposta, risulterebbe incentivante nei confronti della società per una graduale emersione di materia imponibile, permettendo allo Stato di recuperare gettito nel medio periodo.
La patrimoniale societaria non è nuova per l’Italia. Fu applicata come misura straordinaria nel 1947, abolendo al contempo quella ordinaria che era stata introdotta nel 1940. Prima della riforma del 1973, esisteva l'”imposta speciale sulle società” che colpiva il valore netto del capitale con un aliquota dell'1% ed il profitto quando questo eccedeva il 6% del valore del capitale netto. A differenza della vecchia imposta, la Mat non dovrebbe operare come addizionale ma come tassa di scopo, finalizzata ad esempio all’innovazione tecnologica e al maggior sfruttamento possibile della capacità produttiva esentando parte del “patrimonio immateriale”. Dall’imponibile si potrebbero dedurre i debiti o il patrimonio, in dipendenza dalle finalità ulteriori che il fisco vuol perseguire, diventando un ulteriore strumento di incentivo di capitalizzazione patrimoniale delle società. In Messico dove è già stata introdotta, sono indeducibili i debiti nei confronti delle banche, mentre sono deducibile i finanziamenti dei soci.
La Mat agirebbe solo sulle società e non sulle persone fisiche. Se introdotta come imposta alternativa alle esistenti, svolgerebbe una funzione antievasiva analoga ai condoni. Se addizionale, avrebbe una funzione propria in base agli scopi assegnati alla politica tributaria. Questo genere d’imposta, operando sugli “assets” aziendali e non su i profitti, non va contro il perseguimento del guadagno, tutt’altro, gli imprenditori sarebbero indotti ad un migliore uso dei mezzi propri e alla più alta rotazione possibile degli attivi. Si favorirebbe inoltre il processo di aggregazione delle imprese, in particolare per quelle più piccole, per poter trarre un qualche beneficio congiunto dagli investimenti in ricerca e sviluppo.
Un imposizione societaria più equa ed efficiente, ha bisogno di un giusto mix tra imposte patrimoniali presuntive e quelle basate sulle reali capacità contributive, al fine di perseguire un’imposta marginale che possa dare un gettito certo e sicuro nel tempo e ridurre l’evasione fiscale. L'incertezza macroeconomica può avere effetti più pesanti sui conti pubblici rispetto alla rinuncia a priori di un imposta patrimoniale. La Mat, riduce le distorsioni settoriali a causa dell’alta varianza di intensità capitale attraverso i diversi comparti. Un idoneo sistema di crediti d’imposta, esenzioni e riduzioni, potrebbe inoltre modulare la Mat con riferimento alle dimensione delle imprese e, soprattutto, agevolare quelle nuove. Un imposta patrimoniale, potrebbe trovare un accettazione trasversale, colpirebbe le società “statiche” e non quelle operative. Essendo legata all’attivo non colpirebbe le società ad alto contenuto di lavoro, i professionisti, gli artigiani o le società che producono innovazione. La Mat potrebbe costituire il primo gradino di accettazione di una tassazione di tipo patrimoniale estesa, già di fatto applicata con l’IMU, per andare oltre a misure di imposta patrimoniale del passato legate all’emergenza, come è stato, ad esempio, la tassa sui conti correnti o il contributo straordinario per l’Europa.
Tra le misure anticrisi internazionali c’è il rischio di un ritorno al protezionismo come difesa delle industrie e dei prodotti nazionali in un momento di crisi. Il pensiero di Friedrich List torna d’attualità.
Zollverein è il termine che identificava l’accordo di unificazione doganale degli stati tedeschi preunitari del 1834 per la libera circolazione delle merci. Questo accordo protezionista, nacque dall’intuizione dell’economista tedesco Friedrich List che riteneva importante che ogni nazione sviluppasse al suo interno tutte le attività economiche, specie quelle nascenti, proteggendole dalla concorrenza degli altri paesi per permettere di accrescere il proprio potere in ambito internazionale. Tale misura non sarebbe stata un provvedimento egoistico in quanto tendente verso “l’obiettivo superiore dell’umanità, ossia la futura confederazione universale”.
List criticava il libero scambio senza regole, in quanto reputava che alcune misure protezionistiche potessero essere utili all’economia nazionale. Considerazione nata dall’osservazione della potenza coloniale inglese dell’epoca, dalla sua capacità di proteggere le proprie merci a danno della concorrenza estera. Il libero scambio in effetti, come è sotto gli occhi di tutti, avvantaggia le nazioni più forti se sono le stesse a dettare le regole. List osservava che il sistema commerciale del suo tempo era regolato sulla capacità delle nazioni più ricche di comprare a poco e di rivendere a tanto secondo un principio meramente “predatorio”. Per List la facoltà di produrre ricchezza era più importante della ricchezza in se per se.
List è da considerarsi un liberale atipico per la sua epoca in quanto, non escludeva l'intervento dello Stato nell’economia per difendere, anche attraverso dei dazi protezionistici, il mercato interno. Per lui il liberismo era uno strumento con il quale i paesi economicamente sviluppati si avvantaggiavano sui paesi “ritardatari” ed il protezionismo non era altro che la contro-misura, altrettanto liberale, con il quale i paesi “ritardatari” si proteggevano dalla concorrenza dei paesi più consolidati. Quando il governo tedesco scelse la via protezionistica, i cartelli nazionali elevarono i prezzi favorendo i profitti nazionali e la Germania recuperò velocemente il suo ritardo economico. L’”egoismo” nazionale, in un ambito ridotto, permette di recuperare i gap di crescita interni rispetto agli altri paesi. L’attuale sistema del commercio mondiale, nonostante la globalizzazione ha delle analogie con il sistema tedesco della metà del XIX secolo. Nazioni che si uniscono, abbattono le proprie barriere doganali aiutano con i sussidi le più arretrate per permettere loro di raggiungere un soddisfacente livello di ricchezza. E’ in breve la storia dell’Unione Europea e in generale dell’Ocse. Questo ha permesso ai paesi più sviluppati, di guadagnare delle rendite di posizione, fino a quando un sistema più ampio, come il WTO ha dettato regole nuove per tutti con le stesse finalità idealistiche di List: perseguire una crescita armoniosa mondiale e diminuire le differenze di sviluppo tra le varie nazioni. Il problema è che l’attuale recessione ha messo in crisi questo “virtuoso” meccanismo: “è finita in Europa l’età dell’oro”, che il terzo mondo continuasse nell’autoconsumo, a produrre merci a basso prezzo a beneficio dei i salariati Europei e a non comprare petrolio e materie prime. Ora la nostra rendita di posizione si sta via via deteriorando, con la velocità che contraddistingue i cambiamenti mondiali. Per uscire dalla crisi, alcune nazioni non hanno esitato a proteggere la propria industria e l’occupazione interna con manovre di fatto protezionistiche. Il volume degli scambi si sta riducendo in misura più che proporzionale alla produzione industriale e più rapidamente di quanto avvenne nella crisi degli anni trenta. I tre quarti del commercio mondiale avvengono all’interno di aree di libero scambio: l’Unione Europea, il Nafta per gli stati Americani o l’area Ocse, dove la tariffa è obbligatoriamente quella del Wto, i margini di manovra non sono illimitati. Alcuni Stati hanno adottato delle misure protezionistiche lecite, come quelle di alzare i dazi doganali fino al massimo consentito, altri si stanno proteggendo in modo indiretto: più controlli alla dogana, abuso di misure antidumping, sussidi alle imprese nazionali o introduzione di nuovi standard tecnici e di sicurezza per i prodotti a svantaggio di quelli d’importazione. Ma quello che preoccupa di più e che si stia anche abusando di altre misure di difesa, spesso “illegittime” che sfuggono al controllo del WTO, anche perché il rischio di sanzione è molto ridotto ed è di fatto limitato alla mera cancellazione della misura illegittima che peraltro, ha luogo normalmente almeno dopo due anni e mezzo l’inizio della procedura, permettendo agli Stati colpevoli di proteggere illegittimamente determinati settori della propria economia per un periodo di tempo piuttosto lungo. Misure a limite degli accordi internazionali che adottano un po’ tutti anche perchè nessuno Stato intende rinunciare a priori della propria Sovranità nel proteggere in qualche modo la propria economia.
Il dibattito sul ritorno al protezionismo ed un allentamento delle regole del WTO per uscire dalla crisi, è comunque riaperto. Ad esempio ma una manovra che faciliterebbe l’acquisto di prodotti e merci Italiane a scapito delle altre, troverebbe estremo favore nell’opinione pubblica e nel governo, ma non sarebbe consentita dalle attuali norme della concorrenza internazionale.
Quali ricette dunque per uscire dalla crisi? Il modello classico del capitalismo liberista di stile Reganiano o Thacheriano degli anni ottanta sembra ormai tramontato ed inapplicabile: poche tasse, molto capitale privato in libera circolazione, flessibilità per le imprese, sono fattori che producono il miglior ambiente per l'efficienza del capitale ma senza adeguate politiche dei redditi e di ammortizzatori sociali, si rischia di divaricare sempre più il rapporto tra ricchi e poveri. E’ altrettanto tramontato il modello Scandinavo, che ha tentato un compromesso tra creazione liberista della ricchezza e redistribuzione socialista. Alla lunga il costo della burocrazia, dell’assistenzialismo e delle tutele tendono a deprimere la creazione della ricchezza, disincentivare l’industria, producono tasse più elevate e rendono sistematica la tendenza all'indebitamento statale in situazioni di bassa crescita economica.
Purtroppo oggi tutti gli Stati sono incardinati in un contesto di regole più ampie dei singoli confini nazionali ed il capitale, fonte sia di ricchezza che di base imponibile, si muove e circola liberamente indipendentemente dalle logiche territoriali. Il nuovo capitalismo sceglie legalmente in quali Stati farsi tassare e va dove i costi, compreso quello del lavoro e della burocrazia, sono più bassi, indipendentemente da logiche nazionali, protezionistiche o solidaristiche, rendendo di fatto alcune misure di politica economica nazionale inefficaci. Viviamo in un regime dove gli Stati sono in un certo modo a sovranità limitata, perché il mercato muove i capitali liberamente oltre i confini nazionali e quindi necessario orientare le scelte economiche verso la semplificazione, lo snellimento burocratico, l’abbattimento dei vincoli d’accesso alle professioni e ai mercati, favorire la mobilità lavorativa sul territorio e la rapida riconversione delle risorse umane, affinchè il capitale possa trovare entro i confini nazionali la giusta allocazione e la giusta tassazione. Gli Stati che non ci riusciranno decadranno inesorabilmente: in una prima fase cercheranno di mantenere in vita l’inefficiente macchina statale e di proteggere con barriere protettive le proprie industrie, ma poi quando non avranno più risorse e capacità di indebitarsi, saranno costretti a liberalizzare con procedure d'emergenza con un maggiore costo e disagio sociale.
Le teorie di List comunque non ebbero molto seguito dai teorici dell’epoca e in un certo modo superate dalle successive teorie più complesse. Il protezionismo era giudicato illiberale all’epoca come ad oggi, ma storicamente il suo uso e spesso abuso, ha dimostrato che è stato ed è, il sistema più rapido per garantire rendite di posizione per chi ha la forza politica ed economica per farlo. Certo è che nell’economia reale dove ci si scambiano merci, diversamente dalla finanza di questi ultimi anni dove ci si scambiano derivati e prodotti strutturati, il gioco non è mai a “somma zero”: il vantaggio di un paese crea uno svantaggio per altri ed è per questo motivo che ci si è dati delle regole internazionali ed è stato creato il WTO. Forse non sarebbe stato male che qualche anno fa la stessa cosa fosse stata fatta anche per la finanza internazionale, dove non è sembrato “strano” che tutti guadagnavano e nessuno perdeva.
Il nobel per l’economia 2002 agli studi sulla ricerca psicologica applicata alla scienza economica.
Il premio Nobel per l'economia del 2002 fu assegnato agli americani: Daniel Kahneman per ''aver integrato la ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente per quanto riguarda il giudizio umano e il processo decisionale in condizioni di incertezza'' e a Vernon L.Smith, per ''aver stabilito esperimenti di laboratorio come uno strumento di analisi economica empirica, specialmente nello studio dei meccanismi alternativi di mercato''.
In un momento di grossa recessione finanziaria, dove vengono bruciati milioni di dollari dall’andamento negativo delle borse, l’Accademia Svedese delle scienze ha premiato Daniel Kahneman per i suoi studi che analizzano l’irrazionalità umana nelle decisioni finanziarie e l’ultra liberista Vernon L.Smith che sostiene che i mercati si autoregolamentano anche senza interventi esterni, attraverso i suoi studi empirici sull’euforie e i crolli di borsa.
Kahneman, non è un economista di formazione ma uno psicologo, ha effettuato le sue ricerche per lo più con Amos Tversky ora scomparso, ha fondato i suoi studi sull’analisi dei processi decisionali umani nell’economia con un approccio psicologico.
Il suo assioma fondamentale è che l’atteggiamento verso il rischio in presenza di due diverse alternative, cambia al variare del quadro di riferimento. Ciò può portare gli investitori a ignorare le alternative che sarebbero in realtà migliori rispetto al loro investimento e scelgono invece l'alternativa con il rapporto inferiore. Anche le decisioni prese dalle società di investimento professionale vengono influenzate dal loro quadro di riferimento attuale. Quando i manager si rendono conto che le loro performance sono inferiori a quelle dei loro concorrenti a metà anno, rischiano molto di più nella seconda parte dell'anno.
La gente tende ad essere meno propensa al rischio quando ha una prospettiva di guadagno e più propensa al rischio quando ha una prospettiva di perdita. La gente sembra non calcolare la probabilità alternativa in modo razionale.
La finanza comportamentale ha cercato proprio di migliorare la comprensione di questi processi e di spiegare come le emozioni e gli errori congnitivi possano influenzare gli investitori e il loro processo decisionale. Molti ricercatori ritengono che lo studio della psicologia e di altre scienze sociali possano mettere in discussione le ipotesi dell'efficienza dei mercati e, soprattutto, possano spiegare le anomalie, le bolle speculative e i crolli.
L'11 settembre ha avuto un effetto sui valori collettivi: l'aumento della pratica religiosa, la riscoperta della solidarietà, la crisi del materialismo sfrenato degli anni Novanta. L'economia americana è ancora in recessione, la disoccupazione sta salendo, i profitti delle imprese sono depressi.
L'offensiva terroristica, preceduta dal movimento antiglobalizzazione, seguita dalla crisi Argentina e dai venti di guerra in medio-oriente smentisce la validità di ricette ultraliberiste: l’occidente rimettere in discussione il suo modello di sviluppo e di società. Si riscopre così un filone antico della ricerca economica, quello che contesta l'efficacia del Prodotto interno lordo come misuratore del benessere sociale.
Daniel Kahneman, nella ricerca della felicità, sostiene che gli individui finiscono spesso in una specie di trappola delle aspettative crescenti. Via via che guadagnano di più, e possono offrirsi piaceri e lussi prima irraggiungibili, essi tendono a spostare il livello dei desideri sempre più in alto. «Quel che chiediamo dalla vita — dice Kahneman — è sempre un po' di più di quello che il nostro reddito attuale ci consente di comprare».
Vernon L. Smith, al di la del suo look da vecchio hippy con la sua lunga coda di cavallo, è un teorico del mercato come analisi di laboratorio. Smith è stato il primo a costruire modelli empirici per analizzare i mercati. La volatilità delle borse è più alta sia di quella del mercato del lavoro che di quello delle materie prime. L’andamento apparentemente irrazionale di crolli e bolle speculative conduce in effetti ad un autoefficenza. Smith è un assessore liberista dell’autoregolamentazione dei mercati, ovviamente a condizione che i prezzi espressi siano reali e veri e non “falsi” come hanno dimostrato alcuni dati di primarie compagnie USA.
Il personalismo economico della Chiesa: la sua visione universale dell’agire in campo economico nel pensiero sociale di Paolo VI con l’enciclica Populorum progressio e
di Giovanni Paolo II con l’enciclica Sollicitudo rei socialis.
L’enciclica Populorum progressio di Paolo VI e la Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II si collocano sulla scia del pensiero sociale della Chiesa cattolica tracciato nel 1891 da Papa Leone XIII con l’enciclica Rerum Novarum, nella quale per la prima volta, la Chiesa prese posizione in ordine alle questioni sociali fondando la moderna dottrina sociale cristiana con il riconoscimento della dignità della persona umana nel mondo del lavoro.
Oggi si discute sull’ingerenza della Chiesa nello Stato soprattutto sui temi della famiglia dove il punto di vista laico e quello religioso sono più stridenti, ma in campo sociale ed economico, la visione universale della Chiesa non è molto distante dallo stesso pensiero liberal-socialista.
Mai come in questi ultimi tempi è stata costante l’attenzione della Chiesa ai problemi etici negli affari e nella finanza. La Chiesa con tutti i pontefici succedutesi a Leone XIII, è tornata periodicamente sui temi dell’uomo nell’economica. Recentemente sono stati prodotti due importanti testi sull’argomento, la Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato “Etica, sviluppo e finanza” soffermandosi su quale via deve seguire la finanza per lo sviluppo, sul senso di un’economia orientata più verso il bene dell’uomo anziché i beni materiali; mentre il Consiglio Pontificio della Giustizia e pace, ha pubblicato il “compendio della dottrina sociale della Chiesa” che offre un quadro complessivo delle linee fondamentali del «corpus» dottrinale dell’insegnamento sociale cattolico, un documento di valore etico universale che va al di la del cattolicesimo per proporsi come una traccia di pensiero sociale per tutti.
Il pensiero sociale della Chiesa trova origine dai precursori gesuiti del personalismo economico, nel riconoscimento dei vantaggi della cooperazione interdisciplinare tra economia e società. Con la dottrina sociale, la Chiesa pone delle basi concettuali e metodologiche coerenti fra liberalismo, economia d'impresa e i principi che contemplano la dignità della persona e la sua natura sociale. Concetti teologici e non una nuova ideologia, proposte indirizzate a tutti coloro che liberamente scelgono di accoglierli. Nella Sollicitudo rei socialis, Giovanni Paolo si esprime con queste parole “la dottrina sociale della Chiesa non è una "terza via" tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, neppure una possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa costituisce una categoria a sé”. Anche il personalismo economico nei suoi sviluppi filosofici appartiene la consapevolezza di non costituire vie alternative fra poli teorici più o meno contrapposti. Se la scuola marxista considera la fine del capitale unitamente al capitalismo in quanto nato con esso, la concezione personalistica interpreta il processo economico e dell’uso del capitale in senso logico-naturale e perciò lontana da ogni forma determinismo storicistico.
Proprio il tumultuoso sviluppo economico e la continua ricerca del benessere hanno portato un occidente ricco di denaro ma povero di relazioni umane, tutto l’opposto di ciò che accade nelle società meno sviluppate dove ad una generale povertà permangono ancora forti e stabili i legami interpersonali. Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno dedicato al tema le loro encicliche. Nella Sollicitudo rei socialis, da una concezione strettamente economicistica, che tendeva a identificare sviluppo con crescita e a sottolineare il ruolo chiave dell’industrializzazione e dell’accumulazione di capitale, a una più ampia, che potremmo definire «umanista», che incorpora anche considerazioni che vanno oltre l’economia. Nella Populorum Progessio, fortemente influenzata dalla fine del colonialismo nel terzo mondo negli anni sessanta, la Chiesa si pone, alcuni anni prima dei futuri G8, il problema di valutare le politiche di finanziamento per lo sviluppo non solo nell’ottica di imporre ricette predefinite al fine di garantire la redimibilità dei prestiti con preordinate politiche di privatizzazione, ma di valutare gli aiuti in un ottica di beneficio sociale sull’intero sistema paese. Già negli anni trenta nell'enciclica Quadragesimo Anno, Papa Pio XI precisò che: «la libera concorrenza cioè si è da se stessa distrutta; alla libertà del mercato è sottentrata la egemonia economica; alla bramosia del lucro è seguita la sfrenata cupidigia del predominio; e tutta l'economia è così divenuta orribilmente dura, inesorabile, crudele». Nella Populorum Progressio, Papa Montini riafferma che “lo sviluppo non debba ridursi alla semplice crescita economica. Per essere sviluppo autentico, dev'essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo”. “Non basta accrescere la ricchezza comune perché sia equamente ripartita, non basta promuovere la tecnica perché la terra diventi più umana da abitare. Coloro che sono sulla via dello sviluppo devono imparare dagli errori di coloro che hanno sperimentato prima tale strada quali sono i pericoli da evitare in questo campo. La tecnocrazia di domani può essere fonte di mali non meno temibili che il liberalismo di ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all'uomo ch'esse devono servire.” La Chiesa non è contro il libero mercato, ma contro la concorrenza ingiusta e amorale. La Chiesa è per un economia libera ma inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico.
Il pensiero di Montini fu particolarmente criticato dalla comunità finanziaria dell’epoca, allora poco attenta ad una visione su scala mondiale della finanza e sulle crescenti disuguaglianze tra nord e sud del mondo, visto ancora allo stato coloniale. Paolo VI criticava il profitto inteso come «motore essenziale», la concorrenza assunta come «legge suprema», la proprietà privata «senza limiti né obblighi», «tale liberalismo senza freni conduceva alla dittatura, a buon diritto denunciata da Pio XI come generatrice dell’imperialismo internazionale del denaro». Quindi, sì all’economia reale, no ai nefasti fondamentalismi della finanza globale. L’attività finanziaria moderna può considerarsi oggetto speciale della messa in guardia da parte della Sollicitudo rei socialis che condanna la “brama esclusiva del profitto”. “Si deve denunciare l’esistenza di meccanismi economici, finanziari e sociali che, sebbene essi siano manipolati da persone, spesso funzionano quasi automaticamente, accrescendo la situazione di ricchezza per alcuni e di povertà per gli altri” . Le pratiche finanziarie sono giustificabili se beneficiano anche la società, e solamente se anche la società è beneficata esse dovrebbero essere accettate.
Possiamo crescere all’infinito?
“Crescita”, è l’imperativo per ciascun governo, il primo ed essenziale obiettivo di ogni politica economica. Senza crescita, non c’è sviluppo, non c’è ricchezza ne benessere. Il moderno sistema industriale capitalista richiede come condizione indispensabile una crescita annua dell'economia in base al Prodotto Industriale, il PIL. Quando il tasso di crescita tende a zero, l'economia entra in stagnazione e il sistema rischia di andare in crisi. L’economia e la finanza dovrebbero crescere all’infinito, ma fino a quando è possibile in un mondo fatto di risorse limitate? L'enorme disponibilità di risorse energetiche e l'incredibile progresso tecnologico hanno permesso fino ad oggi di mantenere circa costante il tasso di crescita, creando la percezione che l'economia potesse procedere senza tener conto dei limiti ambientali. L’unico sistema illimitato conosciuto è quello monetario. Oggi coesiste un sistema produttivo retto dalle leggi della fisica e della natura che ha orizzonti limitati, che nonostante imprevedibili progressi scientifici, non può prescindere dalla quantità delle risorse esistenti, ed un sistema finanziario, la cui innovazione, spesso legata a prodotti e transazioni scarsamente trasparenti, consentono una moltiplicazione illimitata del denaro. Tanto per avere una dimensione, il volume dei derivati finanziari attualmente in circolazione, è pari al Pil dell’intero pianeta. La catena del denaro non si può spezzare e continua a moltiplicarsi come nessuna altra attività produttiva potrebbe mai permettersi. Quando gli interessi e le plusvalenze sono più alti del profitto sulla produzione, per quale ragione il denaro dovrebbe affluire alle imprese produttive? I due paesi più popolosi: Cina ed India, con gli impressionanti aumenti di PIL, già incidono pesantemente sulle risorse disponibili, il consumo pro capite dei paesi OCSE è circa tre volte quello medio mondiale, più che di economia sostenibile bisognerebbe parlare di bieconomia: la natura non è un sostituto perfetto del capitale, non è un fattore produttivo illimitato.
L’attuale crisi in effetti è il risultato di una crescita non più sostenibile. La finanza è cresciuta troppo velocemente nel corso degli ultimi decenni, raggiungendo un'ampiezza insopportabile per l'economia reale. Frederick Soddy, nobel per la chimica, già nel 1926, aveva già spiegato questa relazione: la crescita dell'economia reale si basa sulla crescita della produzione e del consumo, crescita che a sua volta implica un aumento dello sfruttamento del lavoro umano e della natura. La valutazione economica dell'utilizzo delle risorse e dell'inquinamento provocato è notevolmente sottostimata, ed è questo errore che rende possibile la continua crescita del PIL.
La finanza cresce sull’effetto leva del credito, scommettendo su una crescita indefinita nel futuro che permetta di restituire gli interessi e i debiti accumulati. Quando l’economia reale cresce, riesce a ripagare i debiti contratti, quando rallenta i debiti si accumulano con un effetto amplificativo. Data la stabilità del volume dei salari e della spesa pubblica negli ultimi anni, il divario oggi esistente tra gli incrementi delle masse monetarie e la produzione reale, non può che spiegarsi con la speculazione. Sono già in molti a sostenere che tutta la ricchezza reale non sia già più sufficiente a garantire l'enorme debito generato dal sistema finanziario, ma anche se lo fosse, il prezzo da pagare in termini di benessere, potrebbe essere molto alto. Oggi la Cina consuma una percentuale del suo prodotto interno lordo inferiore a quello che risparmia, l’avanzo nella bilancia commerciale è investito in gran parte in titoli di Stato Americani, di fatto finanzia gli acquirenti dei suoi stessi prodotti. Ecco perché la crisi in corso è strutturale, sta già cambiando la geopolitica del capitale e se ne potrà uscire solo con cambiamenti di sistema.
Il tasso d’interesse è oggi tenuto basso per permette alle imprese di investire e alle famiglie di rendere meno conveniente il risparmio ed aumentare i consumi, anzi su questi livelli, le stesse per acquistare, ricorrono addirittura al credito al consumo, come è successo negli Stati Uniti negli ultimi anni. Il capitale si moltiplica fino ad un boom irrazionale: ci si indebita nella speranza di guadagni eccezionali e quando la crisi scoppia, i scenari sono fondamentalmente due: o si va in deflazione da debiti come nel 1929 o devono intervenire le banche centrali come prestatori di ultima istanza, affiancate da un aumento della spesa pubblica per sostenere i profitti monetari.
Oggi si è scelta la seconda strada, ma non si è tenuto conto del fattore “incertezza”, anche ad interessi prossimi allo zero, il denaro viene tesaurizzato piuttosto che speso e investito: senza domanda di beni, la crescita economica si trasforma in recessione, la recessione in disoccupazione e la disoccupazione in minori redditi, i minori redditi in minori consumi e investimenti e così via. E’ ciò che Keynes ha definito la trappola della liquidità. Le famiglie aumentano il risparmio che non si canalizza verso le imprese, perché le banche che lo raccolgono hanno paura di prestare a lungo termine. Con una borsa incera i rendimenti delle obbligazioni e dei titoli di Stato restano bassi.
Per uscire dall’empasse, lo Stato dovrebbe aiutare sistema produttivo attraverso l’acquisto dei titoli rischiosi a lungo termine emessi dalle imprese, finanziandosi con titoli di Stato percepiti come a basso rischio. Quando la situazione si sarà normalizzata e quindi sarà diminuita la percezione di rischio del sistema, questi titoli potranno essere rimessi sul mercato, diminuendo il debito pubblico aggiuntivo. Ci sembra l’unica soluzione, oggi le imprese più che investire, tendono o ad aumentare la produttività degli impianti esistenti riducendo l'occupazione, ed è proprio l'accoppiata: deflazione salariale e espulsione di lavoratori dalla produzione che rischia di dare origine ad un ritorno della depressione che si poi inevitabilmente si ritorcerà sul sistema previdenziale e negli assetti dei diritti sociali e del lavoro.
Non si può più pensare ad una crescita continua ed indefinita, un paradigma comune sia ad una visione liberista che marxista. Abbiamo una quantità tale di beni da esserne saturi, stiamo procurando una serie di danni ecologici, sociali e psicologici tali da mettere in discussione che il consumo ed il possesso di beni generi benessere. La soddisfazione raggiunta con il consumo di un dato bene o servizio deve cessare il più in fretta possibile per far posto ad altri desideri o ad altri bisogni. Già nel 1970, l’economista svedese Staffan Linder, aveva mostrato come l'aumento della intensità di consumo conduca alla sua inevitabile diminuzione. Il benessere è sempre più legato alla disponibilità del tempo piuttosto che al possesso, un assunto molto caro al nostro Pontefice che ci parla soprattutto di sviluppo umano, dell’essere opposto a quello disumanizzato dell’avere.
Puntiamo alla crescita, ma il nostro paese è già da qualche anno in decrescita in termini reali, non riusciamo più a garantire il ripianamento progressivo dei deficit pubblici e adeguati servizi di pubblica utilità: sanità, scuola, pensioni ecc. Si assiste ad un aumento della disoccupazione sempre più giovane e scolarizzata, la scomparsa del ceto medio ad una sostanziale riduzione del sistema pensionistico con un rapido invecchiamento della popolazione. Condizioni di decrescita reale si possono individuare nell’aumento considerevole del costo della vita, nei fenomeni di degrado degli ambienti naturali e sociali, nella riduzione dei vincoli di tutela ambientale e dei diritti sociali già acquisiti, così come nelle dismissioni pubbliche dei beni demaniali e dei patrimoni culturali, in corso in molti paesi sviluppati. Le produzioni sono sempre più delocalizzate e l’economia dei servizi non può portare da sola a significativi sviluppi di crescita perché si basa su attività caratterizzate da forti componenti umane non esportabili. I nostri mercati sono pieni di prodotti d’importazione, ma non possiamo esportare i nostri servizi.
Accettare la decrescita, non significa accettare il declino del paese e rinunciare al benessere acquisto, significa ridisegnare il proprio futuro pensando più a cosa lasceremo ai nostri figli, cominciando non solo a preservare le risorse naturali, ma soprattutto a pensare ad un miglior utilizzo di quelle pubbliche.
Lo Stato non può sostituirsi all’iniziativa privata, ma può dare i giusti impulsi: un miglior e chiaro quadro normativo, creare le infrastrutture, non solo tecniche ma soprattutto culturali attraverso una scuola di qualità. Tuttavia non può più prescindere dai limiti imposti dal sistema stesso: una pressione fiscale ormai insopportabile, lo stock di debito pubblico non più amplificabile, ciò significa un'unica ricetta improcrastinabile: maggiore efficienza nella gestione pubblica, meno burocrazia, meno politica e meno evasione fiscale.
La dittatura del debito pubblico: ad estremi rimedi sempre meglio un prestito forzoso di una patrimoniale
Il debito pubblico di ogni italiano oggi cresce di 141,2 euro al mese, un’esplosione quattro volte quella registrata sotto il governo Monti e seconda solo al primo governo Berlusconi che sforò i 165 euro al mese. Il nostro stock di debito ad oggi è pari a circa 36.900 euro a cittadino, neonati compresi. Una cifra enorme che comunque siamo sempre riusciti a rifinanziare alle varie scadenze nonostante la nostra bassa crescita.
Non avendo risorse per fare sviluppo e un elevato carico fiscale, abbiamo fatto ricorso da sempre al debito pubblico. Prima dell’euro, si riusciva con l’inflazione ed il cambio ad utilizzare altri mezzi per rilanciare le economia, ora si ha solo la leva della tassazione e del debito. Solo se il rapporto debito/PIL si mantiene stabile, vuol dire che il paese ha la capacità di creare le risorse per ripagare il debito: il debito è sostenibile.
Non possiamo comunque continuare ad indebitarci all’infinito ed esistono delle dinamiche strutturali che non ci favoriscono: un PIL che non cresce, diminuzione delle entrate fiscali per effetto della recessione, poche possibilità di nuove privatizzazioni, tassi d’interesse che tendono ad aumentare. La contemporanea presenza di un disavanzo primario (spesa pubblica al netto degli interessi meno le entrate tributarie) e di un tasso d'interesse reale (netto inflazione) maggiore del tasso di crescita del PIL non può che far aumentare ulteriormente il nostro debito. Rivediamo uno scenario di fine anni ottanta, ma all’epoca una serie di operazioni straordinarie non ripetibili come: Eurotassa, licenze Umts, condoni fiscali ed edilizi, dismissioni immobiliari, ci permisero di entrare nell’euro, ma la spesa pubblica rimase, ed è rimasta, pressoché invariata. In effetti non è facilmente comprimibile essendo all’80% rappresentata da stipendi statali, pensioni e sanità. L'avanzo primario dell'Italia nei prossimi tre anni potrebbe raggiungere il 4-5% del Pil, dopo essere stato sostanzialmente azzerato nel periodo 2001-2005. Ogni anno l'Italia deve impegnare il 5% del Pil per far fronte alla spesa per interessi passivi, ma oggi non siamo più in grado, se non possiamo comprimere la spesa o aumentare le entrate, c’è bisogno di più crescita.
Nonostante il grosso deficit nazionale, abbiamo comunque ancora dei vantaggi: la nostra posizione debitoria nazionale ha una scadenza sempre più lunga ed in caso di situazioni internazionali turbolente, espone le nuove emissioni a condizioni meno volatili. Solo la metà dei nostri titoli di Stato in circolazione è “in mano” straniera, al contrario dei paesi più esposti come Grecia, Irlanda e Portogallo dove la quota di sottoscrittori esteri arriva anche al 70%. Questo ci rende un pò più indipendenti dalle speculazioni internazionali. Le famiglie Italiane sono ancora poco indebitate e continuano ad avere una certa propensione al risparmio, nonostante che la crisi ha aumentato i debiti e diminuito vistosamente i risparmi sempre più orientati a depositi liquidi più facilmente smobilizzabili nel caso di bisogno.
L’Italia al contrario di altri Stati Europei non è dovuta intervenire per salvare le proprie banche e ciò non ha prodotto aumenti incontrollati del debito, ma la BCE è stata costretta comunque ad acquistare titoli privati con capitali pubblici e garantire i prestiti degli Stati più in difficoltà: Grecia, Irlanda e Portogallo. Le eventuali future perdite, saranno coperte da apposite riserve accantonate dalla BCE. Di fatto la creazione di moneta, il cosi detto “signoraggio”, per aiutare gli Stati membri in difficoltà, ha aiutato il sistema a non sprofondare.
I nostri titoli di Stato non preoccupano ora i mercati internazioni e godono ancora di ottimo credito e solvibilità, ma le turbolenze dei mercati ci obbligano ad una “navigazione sempre a vista” ed è utile pensare già da oggi a possibili rimedi di ultima istanza. Si potrebbero fare maggiori emissioni a scadenze più lontane, ciò che vorrebbe tentare la Grecia, per rifinanziare il debito a scadenza, ma sarebbero più costose in termini di interessi, sempre meglio comunque che un'operazione forzosa di consolidamento come si fece l’ultima volta nel 1926 rendendo inconvertibili per dieci anni i Buoni del Tesoro mediante l'emissione di un nuovo prestito all'interesse del 5%, esente da imposta.
Il federalismo fiscale responsabilizzaerà maggiormente gli enti locali, soprattutto perché la loro autonomia di spesa ha vincoli politici diversi da quelli del governo nazionale ed è spesso utilizzata per mantenere il consenso elettorale. Nella misura in cui non saranno rispettati i vincoli di rientro dai deficit locali, lo Stato seguendo l’esperienza americana, potrebbe togliere in parte la sua garanzia sui debiti locali, abbandonando gli Enti che si ostinano ad essere meno virtuosi ad eventuali default, questo permetterebbe lo svilupparsi di crisi marginali e lo Stato nazionale non correrebbe il rischio di vedere il proprio debito esplodere innescando spirali speculative come in Grecia o Irlanda. Certo il default di un comune o una regione, potrebbe causare conseguenze sociali ad oggi non prevedibili: l’impossibilità di fornire alcuni servizi: illuminazione pubblica, nettezza urbana, bus scuola ecc., azioni legali e pignoramenti sui beni di proprietà dell’Ente, impossibilità di pagare i creditori siano essi banche, privati, altri enti pubblici o gli stessi dipendenti locali.
Il mantenimento consenso elettorale e il susseguirsi di consultazione politiche rende veramente difficile una finanza pubblica attenta sul versante della spesa, ma come è possibile reperire maggiori risorse? Si è di molto alzato il carico fiscale della tassazione sulle rendite finanziarie che ha reso più equo il carico fiscale tra tassazione progressiva del lavoro e quella delle rendite ancorchè da un punto di vista squisitamente liberale il risparmio non è da considerare reddito in quanto costituisce un'accumulazione. Affermava Einaudi: il risparmio non è un flusso finanziario che va al consumo, anzi è la rinuncia ad un consumo presente per ottenerne uno futuro. L’interesse è il prezzo di questa rinuncia. Tassare gli interessi vorrebbe dire creare una discriminazione tra consumi presenti e futuri, vorrebbe dire bloccare il movimento fisiologico dell'attività economica, produttiva e di investimento.
Se non vogliamo mettere le mani nelle tasche degli Italiani ricchi o poveri che siano, con odiose patrimoniali, potremo ammorbidire il prelievo straordinario con un prestito “forzoso”, invece che una tassa, una sottoscrizione obbligatoria di titoli di Stato ad un certo tasso per un certo numero di anni prefissati, in base ad esempio al valore dei beni immobiliari posseduti. Nel 1849 lo fece la Repubblica Romana che obbligava tutti coloro che disponevano di una rendita superiore ai 2000 scudi annui a cederne una percentuale allo Stato, seppure sotto forma di prestito. Nel 1936, per finanziare la guerra in Etiopia, Mussolini emise un prestito doppiamente forzoso sugli immobili. I proprietari di immobili furono obbligati a sottoscrivere un prestito venticinquennale in proporzione al valore degli immobili stessi ed una imposta immobiliare straordinaria fu stabilita per ripagare il nuovo debito. Una manovra “fascista” ma non “capitalista”, ma senza dubbio migliore e più democratica che alzare accise o tariffe o ritoccare le addizionali locali.
Se non tramite il prestito forzoso, si possono infine diluire gli effetti della spesa pubblica posticipando i pagamenti, ad esempio in Italia si ricorse ai titoli di Stato nel 1976, per pagare due anni congelati di scatti della scala mobile. In alternativa si potrebbe proporre ai dipendenti pubblici con gli stipendi più elevati, come avviene oggi nel privato per i premi annuali, la scelta di monetizzare parte degli aumenti retributivi o delle tredicesime in titoli di Stato con un controvalore superiore ad un certo interesse.
Sono comunque tutte scelte non facili anche perché puntare su un aumento del risparmio pubblico, anche se “forzoso”, diminuisce la possibilità di avere reddito disponibile per i consumi e questi ultimi sono indispensabili per far ripartire l’economia e la produzione.
<
Vivere con i tassi a zero. Gesell e la moneta deperibile.
Durante la grande depressione degli anni trenta, un piccolo paese del Tirolo per uscire dalla crisi stampava certificati sostitutivi della moneta. Per accelerarne l’uso e far ripartire i consumi il Sindaco li rese “deperibili”!
Quali effetti economici con i “tassi a zero”? La strategia delle banche centrali è quella di raffreddare ulteriormente le aspettative sui tassi ed evitare che il denaro venga parcheggiato in attività obbligazionarie a breve. Perché sottoscrivere un obbligazione che non rende nulla? Perché il rischio rende di più, ma non è sicuro quanto il titolo dello Stato che da inoltre maggiore qualità al portafoglio degli investitori Istituzionali.
Non sono comunque da escludere interventi ancora più incisivi come concedere direttamente prestiti alle imprese o stampare ulteriore moneta per indurre effetti ricchezza. Si sta in effetti avverando il paradosso di Milton Friedman, che aveva parlato dell'opportunità di “gettare denaro dagli elicotteri” se fosse necessario per aumentare la liquidità al sistema. Per evitare il crollo delle quotazioni si cerca in tutti modi di far uscire il denaro privato e portarlo verso l’immobiliare, le azioni e le obbligazioni aziendali e bancarie che offrono ad oggi rendimenti ben più elevati dei tassi prossimi allo zero dei titoli di Stato, ma ovviamente con un altro rischio.
Se la crescita economica attesa è negativa, meno si consuma, meno si investe e il denaro si tesaurizza non entrando nel sistema, peggiorando ancora la recessione. Ciò è accaduto anche al Giappone, in deflazione negli anni ottanta-novanta: poiché le banche non davano interessi sui depositi, i giapponesi gli hanno messi nel materasso, un buon sistema anche contro l'insolvenza delle banche. In questi casi i rimedi sono due: uno di tipo “keynesiano” e uno “monetarista”. Con il modello Keynesiano, lo Stato si accolla i debiti rischiosi delle banche e delle imprese aumentando il debito pubblico facendo però ricadere su risparmiatori e contribuenti il maggior onere e le colpe delle dissennate scelte di alcuni manager. Più che comprare obbligazioni, sarebbe forse più opportuno in questo caso che lo Stato ne compri le azioni, in modo da far beneficiare poi i cittadini dei futuri utili delle aziende risanate. Alla soluzione del “buon padre” che si accolla i debiti del “figliol prodigo” c’è la soluzione di tipo “neoclassico”, più liberista: attendere che il mercato faccia il suo corso, senza intervento della spesa pubblica,la liquidità farà ripartire l’economia, le banche e le imprese che non riusciranno a far “pulizia” dei propri bilanci falliranno lasciando il campo soltanto ai “sopravvissuti”, ma ad oggi non possiamo permetterci la “legge della giungla”, eticamente più giusta, ma che porterebbe con se una forte disoccupazione e la chiusura di molte imprese.
Ad una situazione economica “unica” come quella che stiamo vivendo, uno dei pochi che ne propose delle ricette per uscirne fuori fu Silvio Gesell, un commerciante tedesco vissuto a cavallo tra il XIX e XX secolo. Non era un economista, ma un socialista utopista ammiratore di Proudhon, anticapitalista ed antimarxista che per primo scrisse una teoria sulla preferenza della liquidità, meglio conosciuta poi come la “trappola della liquidità” di Keynes. Gesell teorizzò la “moneta deperibile”, una moneta che perda nel tempo il suo valore nominale, costringendo i detentori ad affrettarsi a spenderla. Gesell, durante la grande depressione del ’29, comprese indirettamente che a tassi prossimi allo zero, l’unico meccanismo per far riavviare l’economia è quello aumentare la velocità di circolazione della moneta, rendendola deperibile come ogni altra merce. La deperibilità si concretizzava nell’applicazione sulle monete di un francobollo mensile, acquistabili presso le poste ad un costo prefissato, altrimenti il denaro avrebbero perso di un pari importo il suo valore nominale. A questo punto era conveniente spendere le banconote il prima possibile.
Il sistema di Gesell non penalizza i risparmiatori, ma solo chi deteneva il capitale inoperoso, chi non lo spendeva o non lo investiva. Gesell individuava nel tasso d’interesse, il “tributo”, quella parte che è pari al vantaggio naturale di possedere denaro anziché altri beni deperibili. Il denaro viene investito se il suo tasso d'interesse, oltre a retribuire il rischio e compensare l'inflazione, comprenderà anche il “tributo”, altrimenti, verrà conservato liquido.
La teoria di Gensell, aveva degli spunti interessanti, ma trascurava del tutto la necessità di una spiegazione perché il denaro ha usualmente un tasso di interesse positivo, ciò non gli impedì comunque di avere degli estimatori famosi all’epoca. L’idea di Gesell non fu più sviluppata da nessun altro, anche perché non ci furono più casi, fino ad oggi, di grandi depressioni economiche come quella del ‘29.
Tuttavia, con la “moneta deperibile”, Gesell aveva portato una grande raccomandazione pratica che in qualche modo può essere recuperata e rielaborata oggi e proprio durante la recessione degli anni trenta ce ne furono diversi esempi. Il più conosciuto è quello di Woergl, piccolo paesino del Tirolo, dove nel 1931 il sindaco Michael Unterguggenberger, per uscire dalla stagnazione, decise di battere una propria moneta che chiamò “Certificati di Lavoro”, con un valore pari alla moneta ufficiale, ma con una sostanziale differenza, il suo valore, proprio come l’esempio di Gensell, diminuiva dell’1% al mese, a meno di non applicargli sopra un bollo acquistabile in Comune di pari valore. Di fatto la moneta si “svalutava” ogni anno il 12%, ed era meglio spenderla il prima possibile. Il certificato sarebbe stato accettato esattamente come la moneta, anche per pagare le imposte locali. L’emissione comunale era coperta da una pari somma depositata nella banca locale. Ogni detentore del certificato avrebbe potuto presentarlo all'incasso e riscuotere la moneta corrente, ma per scoraggiare questa operazione ed incentivarne l’uso, la banca avrebbe riscosso un aggio del 2%, pari al doppio del bollo e quindi di fatto nessuno lo fece. Non si trattava di moneta alternativa, ma “complementare”, nessuno era obbligato ad accettarla, anche gli stipendi comunali furono pagati con questi certificati. Per incentivarne l’utilizzo, il sindaco propose degli incentivi ai negozianti e così alla fine tutti in paese accettarono questi certificati, proprio per il solo fatto che chiunque altro gli accettava, esattamente come la moneta che circola solo sulla fiducia non esistendo ormai da decenni un corrispondente valore in oro a garanzia del suo valore.
La moneta deperibile, che nessuno aveva interesse ad accumulare, fece risorgere l’economia comunale, aumentare la circolazione monetaria e le entrate comunali con l’introito dei “bolli” applicati sui certificati che in pratica era una sorta di “signoraggio”. Il sindaco per evitare di inflazionare la “nuova” moneta, ne ritirò una parte, fino a lasciarne in circolazione solo un terzo. Chi non voleva spendere, poteva mantenere il valore dei suoi certificati in banca ma a zero interessi. La banca d’altro canto, per non pagare il bollo, cercava di sbarazzarsene subito incentivando i prestiti. La velocità di circolazione dei certificati locali divenne impressionate: mentre la moneta nazionale girava circa 8 volte di mano in 14 mesi, i certificati circa 500. I circa cinquemila scellini della prima emissione fecero muovere beni e servizi per ben due milioni e mezzo di controvalore. Con i bolli mensili incassati, il comune aumentò le entrate che utilizzò in opere pubbliche aumentando l’occupazione. Persino la banca del paese ne ebbe vantaggio, in quanto ora conveniva depositare la moneta nazionale e spendere i certificati, piuttosto che prelevare denaro. Ma fu proprio il clamore dell’iniziativa che ne decretò la fine dopo soli due anni, per evitare l’effetto destabilizzante che avrebbe potuto avere un simile fenomeno su larga scala. Inizialmente il governo Austriaco guardò con favore all’esperimento, ma fu la Banca Nazionale d'Austria a pretenderne l'abolizione perché contraria al monopolio monetario accordato alla banca centrale, benché l'emissione dei era coperta da un pari importo di moneta ufficiale.
L’esempio Tirolese ebbe all’epoca parecchi emuli in tutto il mondo specie in Giappone e negli Stati Uniti. Nel 1933 l’economista liberista Fisher, scrisse un opuscolo: “Stamp Scrip”, per spiegare come funzionavano le banconote bollate e fu fatto anche un disegno di legge, poi bocciato, ai tempi di Roosevelt, per replicare l’esperimento su larga scala.
In Italia, un esempio di moneta deperibile, si ebbe con i “mini assegni” degli anni settanta emessi dalle banche per sopperire alla carenza di moneta spiccia o i vecchi gettoni telefonici. Un affare per chi gli aveva emessi: senza specifiche coperture, convertibili in moneta, stampati su carta comune, accettati da tutti, piccoli, deperibili, spesso venivano collezionati anziché spesi.
Sono moneta deperibile anche i “buoni pasto”: non sono emessi dalla Banca Centrale, sono accettati come il denaro, il negoziante che li riceve paga una commissione all’emittente per avere il controvalore, hanno una scadenza e a volte vanno persi e non spesi. Chi li possiede li spende oltre che per il pranzo anche in quei supermercati che li accettino, questi ultimi in questo modo ampliano il giro d’affari. In effetti anche la “social-card” del governo Berlusconi non è altro che una “moneta deperibile” per incentivare i consumi. Se fosse distribuita a tutti e costasse un po’ meno del valore nominale e perdesse di valore nel tempo se non utilizzata, tutti si affretterebbero ad utilizzarla per non perdere il valore di spesa supplementare.
Forse non è oggi praticabile per problemi legali un certificato comunale deperibile come a Woergl, ma certamente l’intuizione, in un momento di grossa crisi, meriterebbe di essere approfondita.
Sono trascorsi oltre trenta anni dalla rivoluzione burkinabè di Thomas Sankara il “Che Guevara” Africano
Il 4 agosto 1983 il trentaquattrenne capitano dell’esercito, Thomas Sankara, sale al potere con un colpo di stato in Alto Volta ex colonia Francese ai confini del Sahel Africano. Uno tra i più sconosciuti e poveri paesi del mondo sale alla ribalta. Sankara avvia una rivoluzione rurale marxista impregnata da una forte ispirazione religiosa, senza precedenti in Africa, scegliendo l’austerità e l’onestà come percorso di riacquisizione di identità e di fiducia per il suo popolo. Nel primo anniversario della rivoluzione, il paese cambia nome in Burkina Faso, il Paese degli “uomini onesti”. Sankara lottò con forza contro la corruzione, per l’emancipazione femminile e per il sollevamento economico del paese, anche attraverso politiche rigidamente autarchiche. Durante il suo governo, il PIL del paese sali del 4,6%, ed il Burkina Faso fu uno dei pochi paesi africani che videro aumentare il proprio reddito pro-capite, Durante i suoi quattro anni di governo, il paese godette di stabilità, tranquillità e ripresa economica. Sankara peccò tuttavia di un eccessivo estremismo, soprattutto riguardo alla sua politica maoista e leninista e di chiusura totale verso l’occidente, tra i più impegnati nel movimento dei paesi non allineati.
Fu definito in vari modi. "Il presidente dei contadini", per aver nazionalizzato il latifondo agricolo e redistribuito la terra ai contadini, rovinati da tradizioni feudali, dall'avanzata del deserto e dai residui di colonialismo. Fu "il ribelle", per le denunce al sistema pubblico elefantiaco, per le sue proposte in favore del disarmo, dell'equa redistribuzione, dell'indipendenza economica del Sud del mondo. Fu fra i primi precursori dei movimenti a favore della cancellazione del debito estero. Prima del 1983, il 70% del bilancio dello Stato era assorbito dalle spese per la pubblica amministrazione, il bilancio del 1986 era in pareggio. Fu definito anche "il presidente più povero del mondo", per la vita semplice che conduceva facendosi esempio di una politica di non privilegio: "non possiamo essere i dirigenti ricchi di un paese povero". Fu definito anche "l'incorruttibile", per la lotta senza quartiere agli abusi ed ai vantaggi privati. Fu "il difensore delle donne", vittime del patriarcato, che portò ad un deciso miglioramento della loro condizione durante la sua permanenza al potere.
Il 15 ottobre 1987 Sankara venne ucciso da un commando militare e con lui finì la rivoluzione burkinabè, senza particolari clamori. Sankara aveva chiesto troppi sacrifici al suo popolo, allo Stato, ai militari, ai sindacati, ai commercianti, ai capi tradizionali. Di fatto le iniziative populistiche di Sankara non avevano coinvolto veramente la gente, ma erano state subite passivamente.
Pochi giorni prima della morte Sankara aveva affermato: “Abbiamo provato che è possibile eliminare lo sfruttamento, uscire dalla miseria e costruire la felicità per tutti. Quelli che vivono nel lusso sfruttando gli altri ci hanno combattuto e continueranno a farlo. Voi avete di che nutrirvi, ma se la popolazione è nella miseria e continua a restarci, un giorno vi impedirà di mangiare tranquillamente…”
L'esempio di Thomas Sankara e del Burkina Faso ha comunque dimostrato chiaramente che per raggiungere lo sviluppo in Africa è indispensabile perseguire la giustizia sociale, ma anche, che ciò diviene irrealizzabile se perseguito solo con un rigido programma di socialismo reale. L’esperienza di Sankara, seppure contraddittoria, resta comunque un punto fermo nella storia dell’Africa contemporanea.

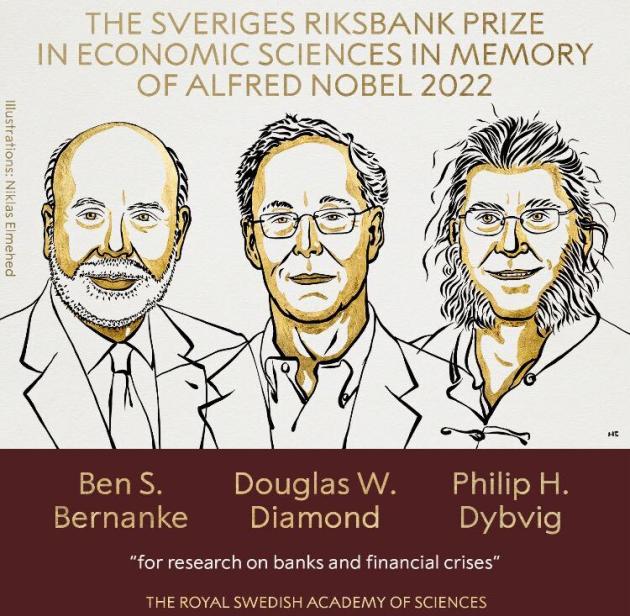




 Oggi sempre più ci si chiede come dare il giusto valore al lavoro e al denaro nella vita delle persone. Con la tecnologia è aumentata la produttività, ma il tempo lavorativo si è espanso anche in periodi una volta deputati al riposo: aperture 24 ore su 24 dei negozi, turni notturni in fabbrica, consumare i pasti in ufficio, pressioni alla rinuncia volontaria delle ferie. In sintesi più lavoro, più soldi, ma meno tempo a disposizione, questa visione miope, ha ricadute negative non solo sui consumi ma anche sulla qualità della vita, in termini di tempo sottratto a sè stessi, alla famiglia e all’impegno civile di ciascuno.
Oggi sempre più ci si chiede come dare il giusto valore al lavoro e al denaro nella vita delle persone. Con la tecnologia è aumentata la produttività, ma il tempo lavorativo si è espanso anche in periodi una volta deputati al riposo: aperture 24 ore su 24 dei negozi, turni notturni in fabbrica, consumare i pasti in ufficio, pressioni alla rinuncia volontaria delle ferie. In sintesi più lavoro, più soldi, ma meno tempo a disposizione, questa visione miope, ha ricadute negative non solo sui consumi ma anche sulla qualità della vita, in termini di tempo sottratto a sè stessi, alla famiglia e all’impegno civile di ciascuno.
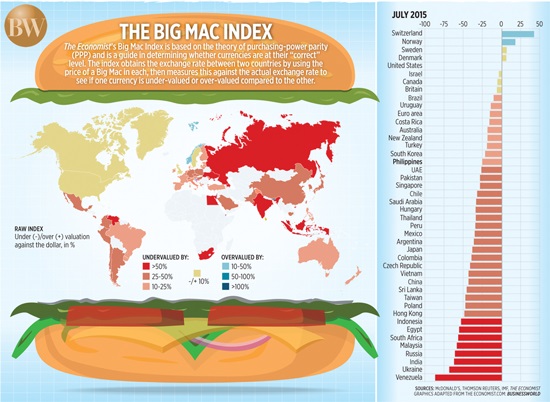
 L’indice del Big Mac misura quanto costa davvero il panino in ogni parte del mondo. Gli analisti comparano il costo del panino in valuta locale ed il cambio ufficiale con il dollaro. Confrontando il risultato con il costo del Big Mac negli Stati Uniti si vede se la valuta locale è più o meno sottovalutata o sopravvalutata rispetto alla moneta americana.
L’indice del Big Mac misura quanto costa davvero il panino in ogni parte del mondo. Gli analisti comparano il costo del panino in valuta locale ed il cambio ufficiale con il dollaro. Confrontando il risultato con il costo del Big Mac negli Stati Uniti si vede se la valuta locale è più o meno sottovalutata o sopravvalutata rispetto alla moneta americana.